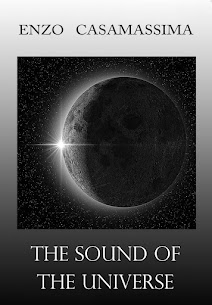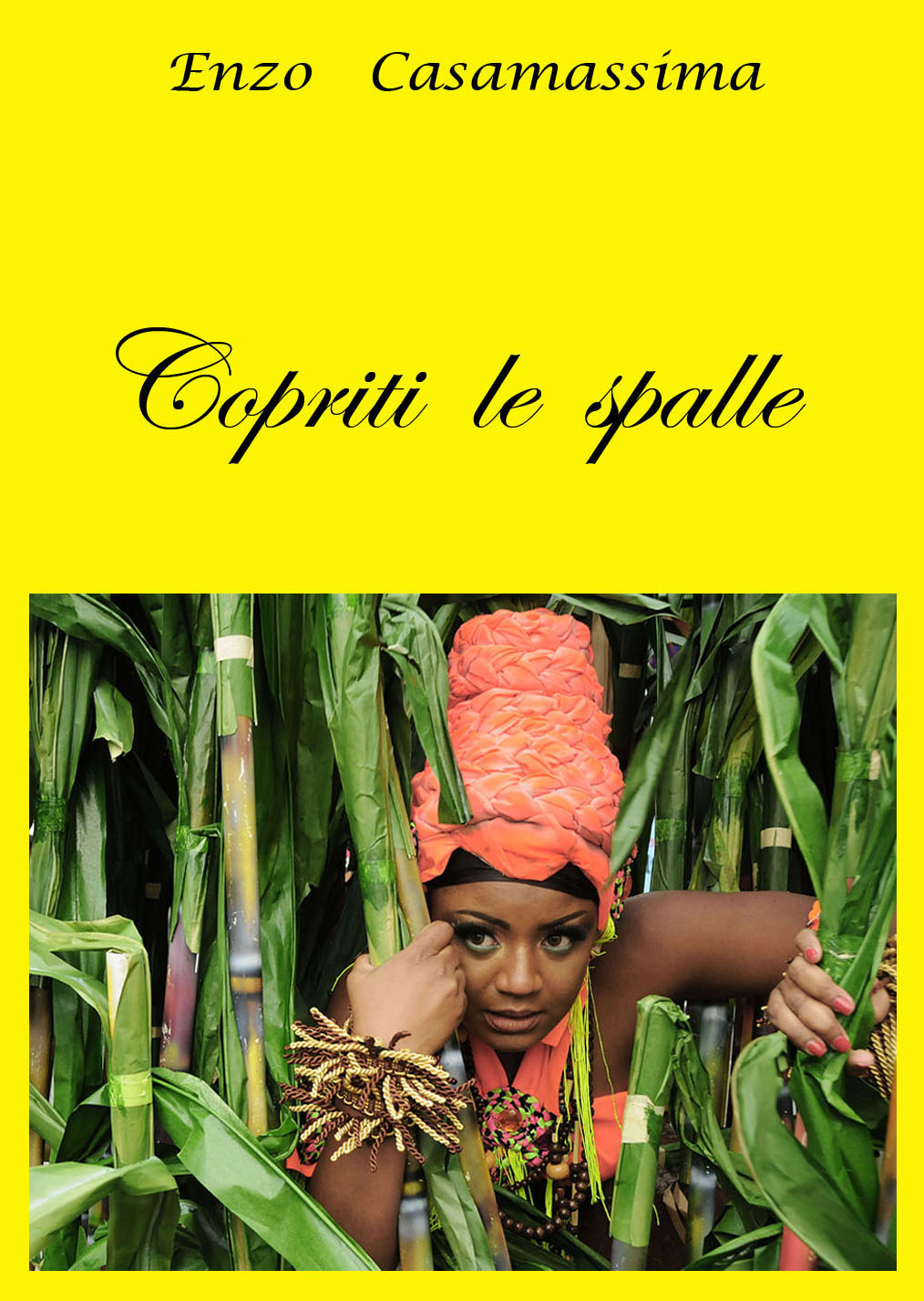Per una corretta visone del blog si consiglia di usare il computer. Con gli altri dispositivi la visione è imprecisa.
Para una correcta visión del blog se recomienda usar la computadora. Con otros dispositivos la visión es imprecisa.
CXXIV Exposición Individual de Fotografías: "Caribbean Faces X" del 11 al 26 de Octubre, en la Galeria de Arte, MAXART.
I Romani
Civis romanus sum. Sono un cittadino Romano. Quando ci si
poteva permettere il lusso di dire questa frase, la vita del dicitore era molto
diversa da quelli che non se lo potevano permettere. Ottenere la cittadinanza
Romana non dipendeva dalla razza, né dalla provenienza. I Romani non erano
razzisti, ma, bisognava sottostare a molte regole, come l’avvenuta
romanizzazione, cioè l’assorbimento dei valori che caratterizzava un Romano ed
esserne degno. Per esempio, chi aveva combattuto per più anni nell’esercito
Romano, la acquisiva.
Dopo un onorevole percorso, uno schiavo poteva diventare un liberto,
cioè libero e poi, acquisire la cittadinanza per meriti. I valori principali
dei Romani erano incarnati nei concetti del mores maiorum che indicava i
costumi, le tradizioni degli antenati, i comportamenti, i valori, le credenze
che tenevano unito il popolo ed erano basate su cinque virtù fondamentali:
fides, pietas, majestas, virtus, gravitas e altre minori come dignitas,
clementia, amicitia, aequitas, decorum, exemplum, pudor, humanitas. Ottaviano
Augusto, da primo imperatore, scrisse sullo scudo aureo conferitogli, le
qualità principali che i Romani dovevano avere: virtus, clementia, iustitia e
pietas.
Fides era la fedeltà, la lealtà, la fiducia, l’onestà tra i cittadini.
Confidare sulla parola, senza contratti, né testimoni. In tutte le culture
antiche, i contratti verbali erano frequenti, ma quando la buona fede era
tradita, la persona offesa poteva intentare una causa.
Il primo tempio in onore di Fides, risale a Numa Pompilio, secondo
re di Roma. Era la dea della buona fede, descritta come una vecchia donna, ma
rappresentata giovane. Si riteneva che la Fides abitasse nella mano destra
dell’uomo, mano usata per giurare. In seguito il gesto fu eseguito in tutti i tribunali
del mondo antico e anche in quelli moderni, alzandola o mettendola su un libro
civile o sacro.
Pietas non era la pietà secondo la nostra accezione. La Pietas era
il rispetto verso gli Dei, la patria, i genitori, i parenti e famiglia.
All’inizio riguardava la famiglia e il rispetto tra coniugi. Poi, l’accezione
del termine si estese tra uomo e divinità; un dovere morale nell’osservanza dei
riti e nel rispetto per gli dei.
Cicerone, nel De Inventione, illustra la pietas come il rispetto del
cittadino nei confronti dello Stato, poi, definita nel De republica, pietas
maxima. Virgilio nell’Eneide identifica la pietas con l’humanitas e la
misericordia, trasformandosi da rispetto per i consanguinei, a pietà per la
sofferenza altrui.
Majestas era la fierezza del popolo che rappresentavano. Essere fieri
dello Stato come rappresentante del popolo. La laesa majestatis, era un crimine
verso lo Stato, verso l’imperatore o il Senato. Majestas era anche l’essere
fieri dell’appartenenza a un popolo o a una razza.
Virtus deriva dal termine latino vir, uomo e rappresentava l’ideale del
maschio Romano. Il poeta Gaio Lucilio sostiene che è virtus per un uomo,
distinguere il bene dal male, conoscere l’inutile, il vergognoso, il
disonorevole.
Gravitas era la tradizione, la dignità, l’autorità, il controllo. Questo
contegno del periodo arcaico e in parte anche repubblicano, in seguito fu
associato alla gentilezza, cortesia e disponibilità. Di fronte alle avversità,
un Romano doveva essere imperturbabile.
Dalla cultura Greca, i Romani impararono la dialettica, la filosofia, la
logica, applicate al diritto, trasformandolo da tradizionalista, a pratico.
Catone il Censore si oppose all’ellenizzazione, ribadendo gli antichi valori e
virtù Romane, contro il degenerare dei costumi del pensiero Greco. Secondo
Cicerone i valori Greci dell’otium e dell’humanitas, favorivano
l’epicureismo e il disinteresse per la politica, in antitesi con il suo
pensiero secondo il quale un Romano doveva interessarsi principalmente alla
politica e alla vita pubblica.
Un vero Romano non ostentava, non si vantava, non si ubriacava, non
trascurava la famiglia, né i propri beni. Un vero Romano aveva un portamento
tranquillo e dignitoso. L’oratore che doveva affascinare la platea lo faceva
con modi eleganti, con voce chiara e contenuta.
L’università di Roma, La Sapienza, congiuntamente con l’università di
Vienna e quella di Stanford, hanno recuperato il DNA dei resti di
centoventisette Romani, in ventinove siti archeologici, in una linea temporale
di migliaia di anni. Comparando gli studi tra le tre università, i risultati
riportano che nel mesolitico che corrisponde al periodo tra gli undicimila e i
novemila anni fa, al temine dell’ultima glaciazione, i popoli Italici non
ebbero influenze e interazioni con popoli di altre zone, in un periodo di
grande stagnazione. Nel neolitico, da 8.000 a 3.400 anni fa, l’uomo scopre
l’agricoltura e l’allevamento degli animali, diventando più stanziale,
cambiando radicalmente il suo modo di vivere. Le genti che vissero in quel periodo
nell’attuale Italia, provenivano dalla Grecia, dalla Turchia e dall’Iran.
Nell’età del bronzo, tra il 3.400 e il 2.600 anni fa, sono state trovate
tracce asiatiche e ucraine con ulteriori migrazioni. Le mescolanze di razze già
in quell’epoca era un fatto rilevante. Nel periodo imperiale, quando Roma era
la più grande città del mondo antico, le mescolanze subirono ancora
un’impennata. Nel V secolo ci fu un’inversione di tendenza, in quanto la
penisola italica risultava invasa dai popoli dell’Europa del nord.
I Romani erano comprensivi con i popoli conquistati. Evitavano
ritorsioni dopo la vittoria, stanziavano milizie per scoraggiare le rivolte, le
quali ricostruivano ciò che la guerra aveva distrutto. Le persecuzioni
cristiane non furono attuate per cause religiose, ma solo per la mancata
accettazione dell’imperatore come capo supremo, da parte dei popoli
conquistati.
I cristiani furono perseguitati sino alla fine del III secolo,
quando la situazione s’invertì e a essere perseguitati furono i pagani. Costantino
aveva cambiato, per motivi strutturali e di opportunità, l’ordine delle cose;
ma la nuova religione, con le sue false regole di libertà e uguaglianza non
condannò la schiavitù. La Chiesa Cattolica creò un potere gerarchico,
assolutista e temporale, con possedimenti sempre più vasti, cadendo nei peccati
da loro stessi deprecati. Tra l’altro, solo il papa poteva sancire la corona di
un imperatore.
L’altezza media della popolazione
Romana, all’epoca dei Cesari, era di 1,65 metri per gli uomini e di 1,55 metri
per le donne. Il peso medio era di sessantacinque chili per gli uomini e
cinquanta per le donne. La vita media di un Romano era di quarant’anni e di
trenta per una donna, poiché molte donne morivano di parto e tanti uomini
morivano in guerra. La lapide del liberto Lucio Sutorio Abascanto, morto a
novanta anni recitava: ... qui vixit annis LXXXX... Per l’epoca, un vero
matusalemme. Ma era l’eccezione.
I bambini Romani affascinati nel sentire
le gesta dei guerrieri, si affrontavano tra di loro in finti combattimenti. I
maschietti giocavano alla guerra, battendosi con spadine di giunco, a cavallo
di una canna, su carrozzini trainati da capre o altri animali domestici o
giocando a nascondino, a palla, a dadi. Le bambine giocavano con il cerchietto,
lanciato con due bacchette. Giocavano a palla, lanciando noci o con le bambole.
La mia generazione non faceva giochi molto diversi.
Nella ricorrenza del solstizio
d’inverno, i bambini ricevevano dei doni. I padri erano severi con loro, mentre
le madri erano più affettuose. A quell’età i bambini non erano equiparati a
esseri umani e per lo stesso motivo, gli Etruschi non seppellivano i neonati
nella tomba di famiglia. Per i Romani la formazione dei giovani spettava alla
famiglia e solo in seguito, al precettore o alla scuola. I bambini non potevano
fare il bagno con acqua calda e dovevano dormire e mangiare poco. L’educazione
primaria tendeva a sviluppare attitudini morali e fisiche, lasciando la cultura
a una fase successiva.
Qualsiasi eccesso era da evitare. La
continentia, l’eccessiva devozione per gli Dei, l’eccesso di cibo o di sesso,
ma anche l’astinenza dai piaceri della vita. Ogni esagerazione, tranne il
rispetto delle leggi e la difesa della patria, era aberrata. Orazio dice che
c’è una misura in tutte le cose. Vi sono dei precisi confini e dove superati si
perde la giustezza delle cose. Nessuno nasce senza difetti, quindi il migliore
è chi ne ha meno. Chi chiede indulgenza per i propri difetti, deve anche
concederlo agli altri. Il denaro doveva essere speso per Roma e non per il
piacere personale.
A Roma i pericoli cominciavano dalla
nascita. Infatti, se si aveva la sfortuna di nascere femmina o minorato, il
padre aveva il diritto di decretarne la morte, tramite esposizione. Mentre, un
neonato maschio e sano, dopo otto giorni dalla nascita, con una solenne
cerimonia era ricevuto dalla sua gens, gruppo di famiglie che avevano un comune
antenato. Tramite la sua opera il figlio maschio avrebbe aiutato i genitori e
curato alla fine della loro vita la loro tomba, celebrando i dovuti sacrifici,
per permettere loro di entrare nell’eden. I neonati erano fasciati come
mummie, lasciando fuori solo la testa e tale usanza si protrasse sino alla metà
del XX secolo. L’esposizione avveniva nelle vicinanze di latrine o discariche,
dove il neonato moriva di fame o di freddo o straziato da animali. A Roma, nel
Foro Olitorio c’era la colonna Lattaria, dove i bambini erano lasciati nella
speranza d’essere nutriti da altri.
Plutarco riteneva la povertà dei
genitori un’attenuante all’abbandono. Lo storico Musonio Rufo denunciava i
genitori ricchi che per assicurare il benessere dei figli preferiti, ne
esponevano altri.
I maschi avevano i tria nomina.
Praenomen, nomen, cognomen. Il praenomen era il primo nome che si attribuiva al
figlio; l’abituale nome con cui veniva chiamato in casa. Negli scritti il
prenome era ridotto all’iniziale. Il nomen era quello legato alla gens; la
famiglia allargata. Il cognomen era un soprannome conferito in seguito, il più
delle volte ricordato con l’appellativo. Talvolta rifletteva qualche tratto
fisico, come con Cicerone, appellativo di un suo avo che aveva un prominente
brufolo sul naso o con Rufus, il rosso, Cincinnatus, il riccioluto,
Brutus, lo stupido, Calvus, il calvo, Caecus, il cieco, Nasica, il nasone,
Dentatus, il dentone. Poi, in epoca imperiale s’iniziò a citare unicamente il
terzo appellativo, poiché talvolta per capirsi poteva bastare. Per esempio,
Traiano e non Marcus Ulpius Traianus. Esisteva anche la supernomina, come
accadde a Publio Cornelio Scipione che dopo la vittoria sui Cartaginesi,
diventò l’Africano. Le donne portavano il solo nome della gens, generando
confusioni, perché tali nomi si ripetevano all’infinito; obbligandole ad
aggiungere un altro nome per distinguerle.
Sulla porta di casa c’era una scultura di Giano. Le
sue due facce erano rivolte una dentro e l’altra fuori della stessa, messa a
protezione e controllo della stessa. La religiosità che il ragazzo praticava,
mirava principalmente a disciplinarlo, spingendolo all’accettazione delle
regole e non verso gli ideali degli dei, poiché i loro comportamenti erano più
esecrabili di quelli degli uomini. Così, imparavano a essere riverenti, verso
la famiglia, le istituzioni e lo Stato.
Il buon Pater Familias teneva spesso il figlio
maschio accanto a lui e per una migliore educazione erano previste le
bastonate, in casa come a scuola. Chi aveva le possibilità, assumeva un
precettore che insegnava al bambino a leggere e a scrivere, sia in Latino che
in Greco e a contare. I precettori più ambiti furono i Greci e gli Etruschi, di
cultura superiore. Nell’Urbe le prime scuole statali furono istituite
attorno al 250 a.C., quindi, a cinquecento anni dalla sua fondazione.
Certamente studiavano meno degli studenti attuali, perché il
piano di studio era composto da solo tre materie, Latino escluso. Quello lo
imparavano a casa, dalla nascita. Il poeta tedesco, Heine, sarcasticamente
disse che se i Romani avessero dovuto imparare il Latino a scuola, non
avrebbero trovato il tempo per conquistare il mondo. Non possiamo dargli torto.
Se il bambino non era di famiglia
abbiente, andava in una scuola pubblica. L’anno scolastico iniziava a fine
marzo e prevedeva un giorno di festa ogni nove. C’erano le vacanze dei
Saturnali, tra il 17 e il 23 dicembre, una pausa invernale e una estiva. Le
lezioni cominciavano all’alba e finivano a mezzogiorno, spesso in un ambiente
all’aperto. I bambini sedevano su sgabelli intorno al maestro, il quale era
seduto su una sedia, tenendo sulle ginocchia delle tavolette incerate e un
bastoncino appuntito per incidere le lettere. Molto tempo dopo fu usata la
carta di lino e la pergamena. Dal II secolo a.C., dagli otto anni, ai
sedici anni erano chiamati puer, mentre le femmine erano chiamate puera o con
il diminutivo di puella.
A dodici anni i maschi passavano al secondo livello d’istruzione,
imparando lingua e letteratura Greca e Latina, storia, geografia, fisica e
astronomia, mentre le femmine si dedicavano ai lavori domestici, come filare la
lana, cucire abiti, cucinare e spazzare. I maschi andavano anche in palestra,
allenandosi sino all’età di 17 anni. Praticavano un combattimento incruento,
con armi in legno senza filo e senza punta, con apposite dotazioni per
difendere la testa, gli stinchi e le braccia, come i gladiatori. Dopo i
diciassette anni il giovane iniziava la vita militare con il vero addestramento
negli accampamenti e nei siti di guerra.
A Roma, i bambini liberi avevano un amuleto al collo, la bulla che
segnalava la loro condizione sociale. A diciassette anni iniziava anche il
terzo livello d’istruzione, dalla durata di due anni. Per chi voleva
specializzarsi si recava ad Atene, Pergamo, Rodi o Alessandria, capisaldi
dell’apprendimento, ad imparare il meglio della cultura. Le scuole furono un
miracolo di cultura e di civiltà, facendo raggiungere un grado di
alfabetizzazione molto alto per l’epoca. Con la caduta dell’impero Romano, la
Chiesa ordinò la chiusura di tutte le scuole pubbliche, lasciando solo quelle
riservate ai preti. La lingua Latina, la lingua universale, la più ricca,
sintetica, efficace, melodiosa e bella del mondo, fini miseramente tra le spire
dei dialetti, imbarbarendosi.
Nella Roma arcaica la moglie entrava a far parte della famiglia del
marito anche in senso economico e religioso, ereditando i suoi beni nel caso di
adulterio o se beveva del vino a sua insaputa. Dal controllo del reato nacque
il bacio che tutti praticarono per altri scopi, giacché per accertarsi se la
moglie avesse bevuto, il marito annusava la bocca aperta della possibile fedifraga.
Queste leggi matrimoniali sopravvissero per secoli, ma mezzo
millennio dopo la nascita di Roma, si cominciarono a diversificare. Per
esempio, Spurio Carvilio divorziò per accertata sterilità della moglie.
Le lamentele più ricorrenti dei Romani erano sul traffico cittadino. I
carri scorrazzavano numerosi nelle strade dell’Urbe, congestionando le strade e
spingendo Giulio Cesare, nel 45 a.C., a emanare una legge che permetteva solo
la circolazione dei veicoli per il trasporto di merci e cibo. Il traffico privato
fu vietato dall’alba al tramonto, anche se la legge non fu seguita nella sua
interezza. Il rumore era un’altra delle caratteristiche sgradevoli della città.
Marziale disse: “A Roma non esiste un posto dove un poveretto possa meditare o
riposare. Al mattino non ti lasciano vivere i maestri di scuola e la notte i
fornai. L’orefice picchia con il mazzuolo l’oro della Spagna. Dall’altra parte
non smettono i fanatici del culto di Bellona di chiacchierare e vociare.”
Altro elemento di lamentela era la sporcizia. I liquami venivano buttati
in strada dalle finestre, provocando un lezzo insopportabile e i tintori dei
tessuti usavano la orina per il loro lavoro, infestando l’aria. La crisi degli
alloggi e i suoi alti prezzi era un’altra lamentela usuale tra i Romani. Anche
i vagabondi causavano lamentele, per le loro richieste inopportune. Pur
essendoci dei vigili che dirimevano le questioni, di notte, camminare per
l’Urbe era pericoloso.Tutte le leggi approvate erano discusse dalle assemblee.
La prima era l’assemblea della plebe, organizzata su venti tribù, entità
territoriale, quartieri della città che eleggevano il tribuno della plebe che
aveva la possibilità di bloccare le leggi di altre assemblee, se credeva che
potesse ledere gli interessi della plebe. La seconda era quella dei comizi
tributi, organizzati in trentacinque tribù, sempre su entità territoriali, i
quali eleggevano le magistrature minori, come i questori ed edili. Gli edili
controllavano i mercati, le strade e organizzatori di giochi. I questori
organizzavano le finanze di una zona, riscuotendo le tasse e gestire le finanze
di una entità territoriale. Un’altra assemblea era quella dei comizi
centuriati, organizzati in cento novantatré centurie, le quali non erano
organizzate su entità territoriale, ma sul censo, sulla ricchezza.
Le prime novantatré erano degli uomini più ricchi di Roma, eleggendo le
magistrature principali. Eleggevano i pretori, l’attuale magistrato, i quali
intervenivano quando c’erano delle diatribe inestricabili, interpretando la
legge. La carica dei censori controllavano che i futuri senatori che avessero i
requisiti, si occupassero del censimento della popolazione e il decoro delle
città. Infine i comizi centuriati eleggevano i consoli, uno degli optimates e
uno dei populares, la più alta carica dello Stato. I due si controllavano a
vicenda e comandavano a giorni alterni. L’assemblea dei comizi curiati, la
prima a essere formata, nel tempo perse d’importanza ed era presente solo
simbolicamente.
Il senato, sempre presente nella storia di Roma, ai tempi di Romolo
chiamato consiglio del re, era formato da trecento senatori, tutti ex
magistrati che dopo alcuni mandati potevano confluire nel senato, senza poter
legiferare, ma solo con funzione di controllo, dando voce agli aristocratici,
approvando situazioni politiche e pubbliche, come finanziare le legioni,
dichiarare guerra. Il loro potere dialettico era la parte più spettacolare
nella vita pubblica, militare e politica di Roma.
Oggi come ieri, il
problema più importante per gli uomini era la zazzera. Quando diventava bianca
se la tingevano e quando compariva la calvizie, usavano il riporto. Famoso
quello di Giulio Cesare. Si ricorreva anche al nerofumo per colorarli, oppure
alle parrucche. Affari d’oro facevano i venditori di lozioni miracolose per la
crescita dei capelli. Ovviamente inefficaci
Fin dal III secolo a.C., era di moda tra i
Romani sbarbarsi, ma dopo Adriano la maggior parte degli imperatori non lo fecero.
Da amante della cultura Greca, nel
II secolo, Adriano si lasciava crescere la barba facendola ridiventare di moda a Roma, ma anche perché aveva una
cicatrice da nascondere. Dopo i quarant’anni,
molti se la facevano crescere come segno di saggezza e di comando, da cui il
detto Latino: “Barba virile decus et sine barba pecus.” La barba è un decoro
dell’uomo e chi è senza barba è una pecora.
Presso altri antichi popoli la barba era considerata un
simbolo di potere. I sumeri si radevano la barba e si tagliavano i capelli, ma
nel I millennio a.C., portavano la barba squadrata e arricciata. In Egitto
radersi era considerata una regola igienica e un dovere religioso, mentre i
nobili si radevano il corpo e mettevano parrucche colorate e inanellate.
Nell’antica
Grecia la barba era ritenuta segno di forza e di virilità. Gli ateniesi
Temistocle, Pericle, Milziade e gli spartani Pausania e Leonida portavano una
barba corta e curata. A Sparta, i codardi erano condannati a portarla su
un solo lato del viso, in modo che fosse facile distinguerli a distanza.
Alessandro Magno, nel IV secolo a.C., impose ai soldati di radersi per distinguersi
dai nemici ed evitare che potessero essere afferrati per la barba. I Romani non
si radevano, ma nel 299 a.C., Publio Ticino Menea introdusse a Roma i
barbitonsori, reclutatati in Sicilia, al tempo greca e abituati a radersi.
Scipione l’Africano fu uno dei primi a radersi, poi largamente imitato.
Fare la barba
non era un compito facile, poiché i rasoi oltre che essere usati a secco, erano
poco affilati, provocando tagli e infezioni. Nonostante ciò, anche i soldati
negli accampamenti si radevano per mantenere la disciplina e il senso della romanità
e anche gli schiavi erano obbligati a farlo. Giulio Cesare si radeva ogni
mattina e si depilava in tutto il corpo, chiedendo ai suoi soldati di imitarlo,
tanto da indurlo a dire: “I miei soldati si profumano, ma combattono bene.”
Tiberio, Caligola e Claudio si radevano, ma non Nerone, perché odiava che gli
accostassero una lama al collo. Lo stesso, vanitoso come nessuno, pose la sua
prima barba da ragazzo in una pisside d’oro massiccio, offrendola a Giove
Capitolino. I successori Vespasiano, Tito, Domiziano, Nerva e Traiano si radevano,
cosi come Antonino Pio, Lucio Vero, Marco Aurelio, Settimio Severo e Caracalla.
I rasoi in ferro
erano affilati come qualsiasi altro coltello, su delle mole di pietra o su
strisce di cuoio. I Romani s’affidavano al tonsor, il barbiere, privato per i
più ricchi e pubblico per la popolazione, il quale in una bottega o in strada
tosava i passanti che lo richiedevano. Giovenale accusa i tonsores di disturbo della
quiete pubblica, a causa delle urla atroci che riuscivano a cavare dai loro clienti,
a ogni ora del giorno. Lo storico Carcopino, illustra il dramma che
rappresentava per i Romani il radersi, sacrificio affrontato per distinguersi
dai barbari. I tonsores riuscivano nell’impresa di sfregiare e tagliare pezzi di
naso, orecchio e altro. In mancanza di dentisti e chirurghi, a loro era
affidato anche il compito di cavare denti e di cucire le ferite, con risultati
immaginabili. I curiosi stazionavano nei paraggi, vogliosi di novità e
pettegolezzi o per ricevere informazioni e fare affari. Così, Marziale raccontava
le imprese del suo barbiere. “Le stimmate che io porto sul mento, grandi quante
un grugno, le ostenta un pugile in pensione. Non me le ha fatte mia moglie con
le sue unghie, ma il braccio scellerato d’Antioco, con il suo ferraccio.” Poi,
conobbe Pantagasto che con la sua mano di seta gli risolse il problema. Con la
caduta dell’impero Romano, l’umanità si tuffò nella barbarie e le barbe si
riallungarono. La civiltà Romana che aveva illuminato il mondo si spense,
precipitando nell’evo oscuro, dove lavarsi era peccato, ma importante era pregare.
La donna Romana, per un appuntamento galante gradiva che
gli uomini fossero puliti e si profumassero con olii balsamici. Il corpo
maschile più alla moda per la donna era quello abbronzato e atletico. Gli
uomini ricchi si vestivano con un perizoma in lino, chiamato subligar, poi, una
tunica e un camicione in cotone o di lino. Si addobbavano con lingue di stoffa
colorate, le toghe, simili a lenzuola, molto eleganti e curate nelle pieghe,
lunghe circa sei metri. Per la complessità dell’operazione erano aiutati da uno
schiavo. Sopra la toga, nei mesi freddi, usavano un manto che di notte era
steso sul letto come coperta. La toga era un simbolo di cultura e di status che
solo un cittadino Romano poteva vestire. Era proibito vestirsi con abiti dell’altro sesso, eccetto a carnevale o
durante le feste.
Nei secoli la toga subì innumerevoli variazioni. La toga praetexta,
bordata di porpora era indossata da senatori, magistrati e alte cariche statali
e religiose, compreso l’imperatore. La toga praetexta era indossata anche dai
ragazzi sino ai sedici anni. La toga praetexta era di origine Etrusca e
introdotta a Roma da Tullo Ostilio. La bianca toga virilis segnava l’ingresso
nell’età adulta, indossata in una cerimonia.
La toga candida era ancora più bianca della precedente e era indossata da
chi si proponeva per la magistratura. La toga purpurea, interamente di porpora,
era riservata agli imperatori e ai condottieri nel momento del trionfo. La toga
trabea era multicolore e veniva indossata dagli áuguri, i sacerdoti che
rivelavano il volere degli dei, attraverso il volo degli uccelli. La toga sinus
era una stoffa che veniva ripiegata più volte attorno al petto. Comparve
durante il principato di Augusto, indossato dagli imperatori.
Sin dall’inizio della civiltà Romana, l’abbigliamento ha rappresentato la
cittadinanza, il rango e cariche di ogni tipo. Il codice del vestiario era così
rigoroso che le violazioni potevano essere considerate un’offesa per i costumi
della patria. Non si trattava di sola indecenza, ma di un oltraggio alle
istituzioni. Gli abiti erano di lana o di lino, anche se i più abbienti, in età
imperiale usavano anche la seta e il cotone. Il pallium era un mantello di lana
con inserti colorati che si portava sopra la toga. Poi, preferirono indossarlo
sopra la tunica, evitando la complessità della toga. Il progressivo abbandono
della toga da parte dei Romani fu stigmatizzato da Augusto, nel tentativo di
ripristinare gli antichi costumi.
Nel 382, l’imperatore Teodosio emanò una lex vestiaria che prescriveva
abiti per ogni categoria. I senatori dovevano indossare la toga, così come i
clientes che erano i protetti dei patrizi. Gli officiales, funzionari di Stato,
dovevano indossare il pallio. Gli imperatori Onorio e Arcadio emanarono leggi
ancor più restrittive, vietando di indossare i pantaloni, bracae, vestiario dei
barbari. In seguito, con il dilagare dei barbari, queste leggi furono eliminate.
Oramai mancava poco al crollo dell’impero d’occidente.
Le prime calzature dei Romani furono le Solae, sandali
unisex, fissati alla caviglia con una cinghia e usati in casa con il Soccus, calzatura
leggera e bassa d’origine Greca, simile all’odierna pantofola. Le scarpe
erano chiuse come stivaletti o aperti come i sandali, fatte con strisce di
cuoio e chiodate per salvaguardare la suola. Ogni reggimento militare possedeva
una diversa disposizione dei chiodi, per lasciare impronte riconoscibili. Un
disertore non aveva scampo. Poi, i sandali divennero raffinati e sfarzosi,
ornati di fili e fibbie di bronzo, di rame, d’argento e d’oro, di piume
colorate, di ciondoli, di conchiglie. Giulio Cesare portava dei sandali con la
tomaia in oro. Eliogabalo usava scarpe nuove ogni giorno, proibendo alle
matrone di indossare sandali ornati di ricami o di pietre preziose, perché
voleva l’esclusiva.
I Romani non usavano le calze. Le scarpe erano lucidate
con cera d’api e colorate con zafferano per il giallo, sali ferrosi o tannini
per il nero, guado per l’azzurro e porpora per il rosso. Il Coturno, usato
dagli attori tragici, era una calzatura con allacciatura alla caviglia o al
polpaccio e suola molto spessa che elevava la persona. I Calcei erano fatti con suole
nere senza tacco, indossati dai senatori, mentre quelli rossi erano prerogativa
delle alte cariche. Chi camminava molto, come i centurioni e i contadini,
portava le Caligae, calzatura chiusa con suola ferrata.
Per
i Romani la gestualità era essenziale, poiché coloriva ed enfatizzava l’oratoria.
Poi, dopo la caduta dell’impero, la gestualità fu considerata una volgarità. Giulio
Cesare aveva una gestualità armoniosa e contenuta, dando più risalto e carisma
ai propri discorsi.
Nella cultura antica mediterranea, il saluto non
prevedeva un contatto. I Greci, Etruschi e Romani non si toccavano. In Egitto
s’inchinavano. La prima regola del saluto era mostrare la mano disarmata,
chiarendo che si avevano buone intenzioni. Il saluto Romano è ben raffigurato
nelle statue di alcuni imperatori come Giulio Cesare, Ottaviano Augusto o Marco
Aurelio, dove il braccio è proteso in avanti e il palmo è ben mostrato, diverso
dal saluto fascista o nazista. Questo equivoco nacque nel 1914, quando Gabriele
D’Annunzio fu chiamato come consulente nella realizzazione del film muto
Cabiria, ambientato nel III secolo a.C.. D’Annunzio immagina il saluto Romano
utilizzato nel film, come quello che in seguito sarà usato dai regimi fascista
e nazista.
Il pugno chiuso e il medio aperto, nacque in Grecia, poi
passato a Roma, chiamato, digitus impudicus, dito osceno. Il gesto era una
minaccia di sodomizzazione. Il pollice messo tra l’indice e il medio era un
insulto sessuale, ma aveva soprattutto un senso scaramantico e di buona
fortuna. Gratatio pallorum, omnia mala fugat. Grattarsi i testicoli era un
gesto scaramantico di buona fortuna che allontanava tutti i mali. Nella
gestualità Romana, la condanna col pollice puntato verso il basso non esiste.
La condanna era rappresentata dalla mano aperta, con le quattro dita unite
verso il basso e il pollice contro il condannato. Le quattro dita verso il
basso indicavano la sua discesa negli inferi, mentre il pollice puntato contro
indicava la spada che doveva affondare nel corpo.
Testo tratto dal libro sull'Impero Romano:
"Voci dall'Antica Roma"
2025 by Enzo Casamassima. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission.