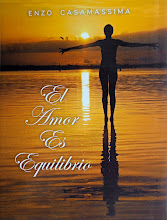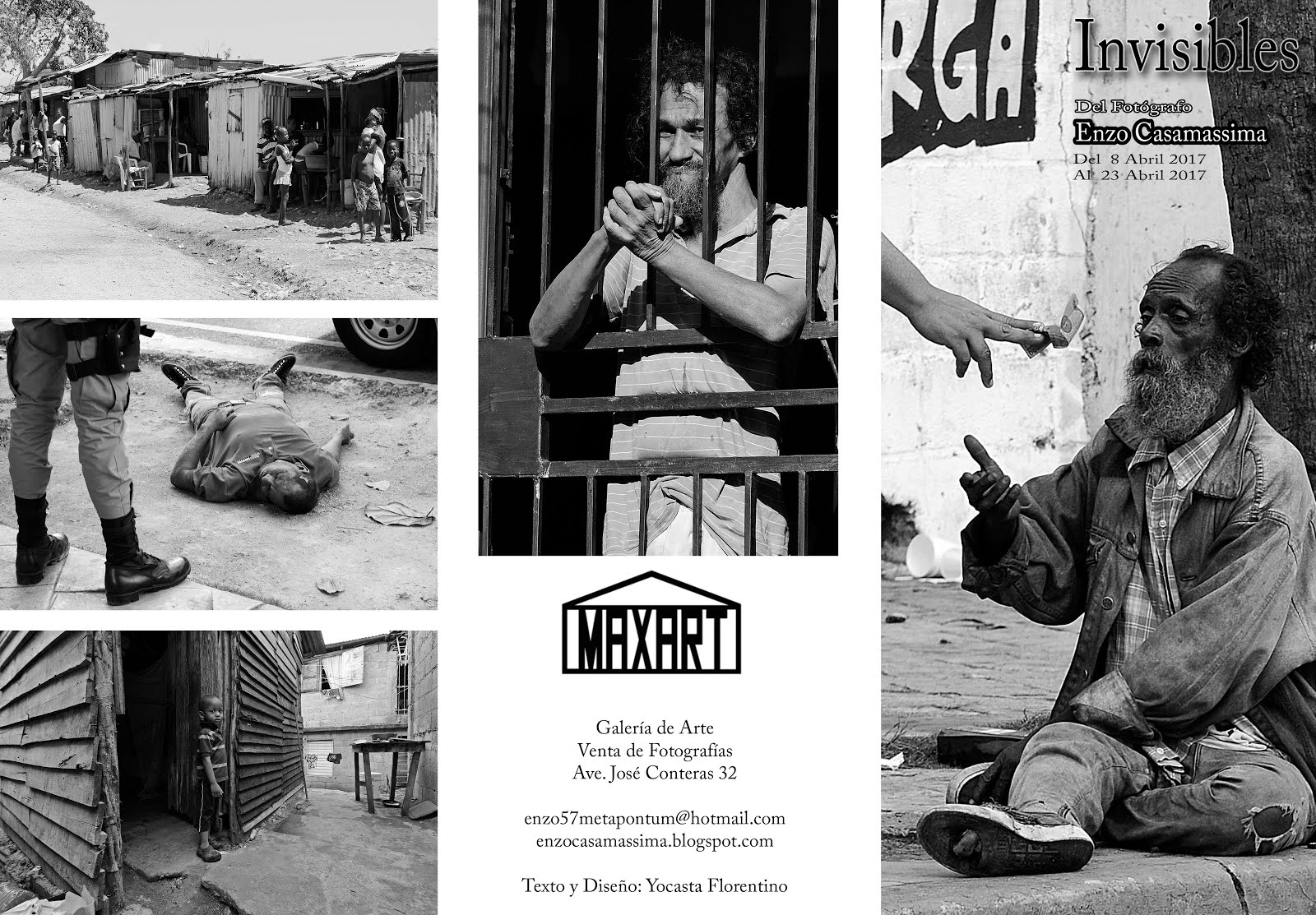LXXIX Exposición Individual de Fotografías: "Paisajes Internos Dominicanos II" del 7 al 22 de Enero, en la Galeria de Arte, MAXART.
Vita del brigante lucano Carmine Crocco
Quarta e Ultima Parte
Il 14 settembre 1863, a Rionero, Giuseppe
Caruso, fino a quel momento uno dei migliori aiutanti di Carmine Crocco, lasciò
la banda e rivelò informazioni sull’organizzazione al generale Emilio Pallavicini,
il quale fece arrestare tutti i parenti dei briganti menzionati da Caruso,
ordinò la sorveglianza delle case sospette e fece travestire gruppi di
soldati da briganti. Per queste misure, il numero di scontri a fuoco favorevoli
al regio esercito aumentò e i briganti catturati, invece di essere
giudicati da un tribunale militare, erano freddati sul posto. Anche i notabili
che avevano fatto promesse d’aiuto a Crocco, intuendo la fine prossima della sua
associazione, presero le distanze per opportunistici sentimenti liberali. Con i
suoi pochi seguaci, Crocco fu accerchiato dai Cavalleggeri di Monferrato e di Lucca e costretto a dividere la sua banda, in gruppi ancora più piccoli, nei boschi di Venosa e Ripacandida. Li trascorse i mesi invernali,
ritornando alla ribalta nel successivo aprile, alla guida di soli 15 uomini. Il
25 luglio 1864, le truppe di Pallavicini lo sorpresero sull’Ofanto, decimando
il suo drappello, riconoscendogli le grandi qualità militari e di guerriglia.
Crocco riuscì a scappare, tallonato dai
regi bersaglieri. Evitando i centri abitati e attraversando monti e foreste, giunse con alcuni suoi uomini nello Stato Pontificio, il 24 agosto 1864, sperando di poter incontrare a Roma, Poi IX, il quale
aveva sostenuto la causa legittimista. Ma, Carmine fu catturato il giorno
seguente a Veroli, dalla gendarmeria del papa e incarcerato a Roma. Gli
eventi suscitarono in lui una profonda delusione, anche perché oltre all’arresto
gli fu confiscata una cospicua somma di denaro. Il 25 aprile 1867, a Civitavecchia,
Crocco fu imbarcato su un vapore delle Messaggerie Imperiali Francesi, per Marsiglia.
Giunto nei pressi di Genova, il governo italiano intercettò il vascello catturando Crocco, ma Napoleone III ne reclamò il rilascio,
sostenendo che non avessero il diritto d’arresto su una nave di un altro
Stato. Dopo un breve periodo di detenzione a Parigi, Crocco fu
rispedito nello Stato Pontificio, a Paliano e con la presa di Roma, da
parte dei Sabaudi, del 1870, passò nelle mani dello Stato italiano, traferito prima
ad Avellino e poi a Potenza.
Per la fama raggiunta, durante i passaggi
da una prigione all’altra, numerose persone accorrevano per vederlo. Durante il
processo tenuto presso la Corte Criminale di Potenza, al brigante furono
imputati 67 omicidi, 7 tentati omicidi, 4 attentati all’ordine pubblico, 5
ribellioni, 20 estorsioni, 15 incendi di case, con un danno di oltre 1.200.000
lire. Dopo 3 mesi di dibattimento, l’11 settembre 1872, la Corte
di Assise di Potenza, deliberò la condanna a morte, con le accuse di
omicidio volontario, formazione di banda armata, rapina, sequestro di persona e
ribellione contro la forza pubblica. Poi, con decreto reale del 13
settembre 1874, la pena fu misteriosamente commutata in lavori
forzati a vita. Altri briganti con capi d’imputazione simili furono
giustiziati. Le ragioni furono a sfondo politico e lo Stato italiano subì il
volere francese. Crocco durante l’interrogatorio, sostenne che le autorità papali
non poterono liberarlo, poiché sarebbero state accusate dal Governo italiano di
favoritismo verso i briganti. Dopo la sentenza, il brigante fu trasportato
nel carcere di Santo Stefano e poi in quello di Portoferraio,
in provincia di Livorno, dove passò il resto dei suoi giorni. Durante la
vita da carcerato, Crocco si mantenne calmo e disciplinato. Rispettato dagli
altri detenuti per l’autorità del suo nome, non si unì mai alle proteste e
baruffe degli altri carcerati, prestando soccorso ai necessitati.
Nel carcere di Santo Stefano, fu visitato
per dieci mesi dal criminologo Pasquale Penta. Nonostante il direttore del
presidio lo definiva pericolosissimo e da tenere sotto stretta osservazione,
Penta non riscontrò in lui tali necessità.
“Capace di grandi reati, ma anche di
generosità, di sentimenti nobili, di belle azioni, la causa della sua carriera
criminale è il germe della pazzia materna. Nella sua attività criminale fu
autore di mille delitti, saccheggi di città, incendi, omicidi, ricatti,
estorsioni, ma, allo stesso tempo cercò di tenere a bada i suoi bestiali subalterni
e trattò a tu per tu con i generali italiani. Imponeva che fossero rispettate
le donne oneste, maritate e zitelle, che non si facesse del male oltre il
necessario e non si eccedesse nella vendetta, per compiere la quale era
inesorabile. A molte ragazze che non avevano come maritarsi, regalò denaro e ai
poveri contadini comprò armenti ed utensili di lavoro.”
Vincenzo Nitti, figlio del medico
massacrato a Venosa, militare della Guardia Nazionale e testimone
oculare dei fatti, lo considerò un ladro per indole, ma anche un brigante non
comune, per astuzia, ardire e per generosità brigantesca. Nel 1902, a
Portoferraio, giunsero gli studenti di medicina legale dell’Università
di Siena, del professore Salvatore Ottolenghi, per intervistare i
condannati, a scopo scientifico. Ottolenghi ebbe un colloquio con Crocco,
considerato il vero rappresentante del brigantaggio dei tempi celebri, definendolo
il Napoleone dei briganti. L’intervista fu pubblicata l’anno successivo da
Romolo Ribolla, studente di Ottolenghi, nell’opera, Voci dall’ergastolo.
Durante la conversazione l’ex brigante, ormai vecchio, con problemi fisici e
dichiaratosi pentito del suo passato, raccontò la sua vita, lasciandosi
andare anche al pianto. Elogiò Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, per
avergli concesso la grazia, anche se negli scritti autobiografici, il
ringraziamento non era per aver avuto salva la vita, ma per aver preservato i
suoi familiari dall’obbrobrio di sentirsi dire che fossero parenti
dell’impiccato. Dichiarò d’essere rimasto scosso dall’assassinio del
re Umberto I, ucciso dall’anarchico Gaetano Bresci. Il suo desiderio
era morire nel paese natio, ma Crocco si spense nel carcere di Portoferraio, il
18 giugno 1905, all’età di 75 anni, di cui gli ultimi 29 passati in detenzione.
Carmine, dotato di un fisico robusto e un’intelligenza
fuori dal comune, era alto un metro e settantacinque centimetri. Fu legato
a una donna chiamata Olimpia. In seguito ebbe una relazione con Maria
Giovanna Tito, conosciuta quando si aggregò alla banda, mettendo fine alla
relazione con Olimpia. Poi, la Tito fu lasciata, poiché Carmine s’invaghì della
vivandiera di Agostino Sacchitiello, di Sant’Agata di Puglia, luogotenente
di Crocco. Nonostante la fine della loro relazione, Giovanna continuò a servirlo
fedelmente, fino a quando nel 1864, fu arrestata. Carmine ebbe una relazione anche
con Filomena Pennacchio, poi compagna del suo aiutante Giuseppe Schiavone.
Durante la detenzione, Carmine Crocco
iniziò la stesura delle sue memorie, realizzata in tre manoscritti, ma il terzo
fu smarrito dal professor Penta. Elaborato con l’ausilio del capitano Eugenio
Massa, fu pubblicato, includendo l’interrogatorio di Caruso, nell’opera, Gli ultimi
briganti della Basilicata: Carmine Donatelli Crocco e Giuseppe Caruso, 1905. Le
sue memorie sono ancora oggetto di dibattito. Secondo Pedio Tommaso, alcuni episodi non erano fedeli. Benedetto Croce disse che le memorie
fossero bugiarde. Basilide Del Zio considerò veri gli scritti, per la descrizione
esatta di persone, luoghi, paesi, campagne, anche se Crocco mentì in molti
punti, occultando molte sue brutalità. Indro Montanelli disse che si
trattava di un componimento viziato dall’enfasi e dalle reticenze, ma descrittivamente
efficace e sincero sulla vita dei briganti. L’opera fu pubblicata più volte da
diversi autori, quali Tommaso Pedio, Manduria, Lacaita, 1963; da Mario
Proto, Manduria, Lacaita, 1994; da Valentino Romano, Bari, Mario Adda
Editore, 1997. Una versione che non subì alcuna revisione linguistica fu
pubblicata dall’antropologo Francesco Cascella, nell’opera, Il
brigantaggio: ricerche sociologiche e antropologiche, nel 1907. Benché una
parte della storiografia dell’Ottocento e inizi del Novecento lo considerasse
un ladro e un assassino, dopo la seconda metà del Novecento fu rivalutato
come un eroe popolare, anche se la sua figura rimane controversa.
Alcuni luogotenenti di Carmine Crocco:
Giuseppe Nicola Summa, detto Ninco Nanco, di Avigliano, condannato per
aver ucciso un aggressore, evase dandosi alla macchia. Si aggregò a Crocco,
diventando uno dei suoi più brillanti luogotenenti. Conosciuto per la sua
brutalità, non compì nessun gesto generoso. Fu ucciso dalle guardie nazionali,
in una imboscata.
Giuseppe Caruso, detto Zi Beppe, di Atella, guardiano campestre,
si diede al brigantaggio, dopo aver ucciso una Guardia Nazionale, nel 1861.
Tradì Carmine informando le autorità, decretando la sua fine. Fu ricompensato
con la nomina a guardia forestale di Monticchio.
Vincenzo Mastronardi, detto Staccone, di Ferrandina, evase dal
carcere per reati comuni, nel 1860. Come Crocco, non ricevette la grazia dopo
aver aderito ai moti unitari. Catturato, fu ucciso nel 1861.
Teodoro Gioseffi, detto Caporal Teodoro, di Barile, guardia campestre.
Arrestato, fu condannato ai lavori forzati a vita.
Francesco Fasanella, detto Tinna, di San Fele, ex militare borbonico,
tornato al suo paese fu schernito per averli serviti, soprattutto da Felice
Priora, un tenente della guardia nazionale. Un giorno Priora gli diede uno
schiaffo, Tinna lo spinse per terra e fuggì nei boschi. La moglie, incinta di
sette mesi, fu fucilata per ordine di Priora. Tinna ammazzò il tenente,
unendosi a Crocco. Si costituì nel 1863. Condannato a vent’anni di
reclusione, fu rilasciato nel 1884, tornando nel paese natio.
Giuseppe Schiavone, detto Sparviero, di Sant'Agata di Puglia, sergente
borbonico, s’unì ai briganti di Crocco per non prestare giuramento all’esercito
italiano. Tra quelli meno efferati, fu condannato a morte tramite fucilazione.
Donato Antonio Fortuna, detto Tortora, di Ripacandida, mandriano, ex
militare borbonico, si dette alla macchia dopo aver rifiutato di arruolarsi
nell’esercito dei Savoia. Ereditò da Crocco, la banda del brigante Di Biase,
dopo la sua morte. Costituitosi a Rionero, fu condannato nel 1864, ai
lavori forzati a vita.
Giovanni Fortunato, detto Coppa, di San Fele, da Crocco definito il
più feroce, temuto dai suoi stessi commilitoni. Non provava pietà nemmeno
verso le persone a lui più vicine, infatti uccise suo fratello perché aveva
saccheggiato una masseria, senza il suo consenso. Figlio illegittimo di un
barone e di una popolana, crebbe nella famiglia di Crocco, il quale era molto
legato a lui. Arruolatosi nell’esercito borbonico e ritornato a San Fele, dopo
la caduta del regno delle Due Sicilie, fu insultato e picchiato da alcuni
compaesani, unendosi alla banda del suo amico. Fu assassinato nel giugno 1863,
forse da Donato Tortora Fortuna, per riparare alla violenza carnale nei
confronti della sua donna, Emanuela, dopo aver ricevuto il permesso da Ninco
Nanco. In un’intervista del 1887, Francesco Tinna Fasanella s’accusò dell’omicidio,
poiché diceva che Fortunato voleva ogni giorno qualcuno da uccidere.
Pasquale Cavalcante, di Corleto Perticara, ex soldato borbonico,
tornato nel suo paese natale fu umiliato. Poi, una guardia nazionale, durante
un diverbio con la madre, la picchiò e le ruppe una costola. Cavalcante vendicò
sua madre uccidendo l’aggressore. Unendosi all’armata di Crocco, fu uno dei
comandanti della cavalleria. Catturato dopo la soffiata di Gennaro Aldinio, fu
condannato a morte a Potenza, il primo agosto del 1863. Prima di essere
giustiziato disse: “Merito la morte perché sono stato assai crudele, contro
parecchi che mi caddero tra le mani. Ma merito anche pietà e perdono perché
contro mia indole, mi hanno spinto al delitto. Ero sergente di Francesco II e
tornato a casa come sbandato, mi si tolse il bonetto, mi si lacerò l’uniforme,
mi si sputò sul viso e poi non mi si diede più un momento di pace, perché
facendomi soffrire sempre ingiurie e maltrattamenti, si cercò pure di
disonorarmi una sorella. Accecato dalla rabbia e dalla vergogna, non vidi altra
via di vendetta che quella dei boschi e così, per colpa di pochi, divenni
feroce e crudele contro tutti. Io sarei vissuto onesto, se mi avessero lasciato
in pace. Ora muoio rassegnato e Dio vi liberi dalla mia sventura.”
Vito di Gianni, detto Totaro, di San Fele, ex gendarme borbonico, fu
tra gli ultimi luogotenenti a essere consegnato alla giustizia, decretando la
fine dell’egemonia di Crocco. Fu arrestato nel febbraio 1865, convinto
alla resa da Giuseppe Lioy, un sacerdote di Venosa, al quale Vito rispose perentorio:
“Fummo calpestati. Noi ci vendicammo. Ecco tutto.”
© 2022 by Enzo Casamassima. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission.