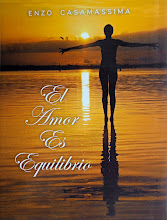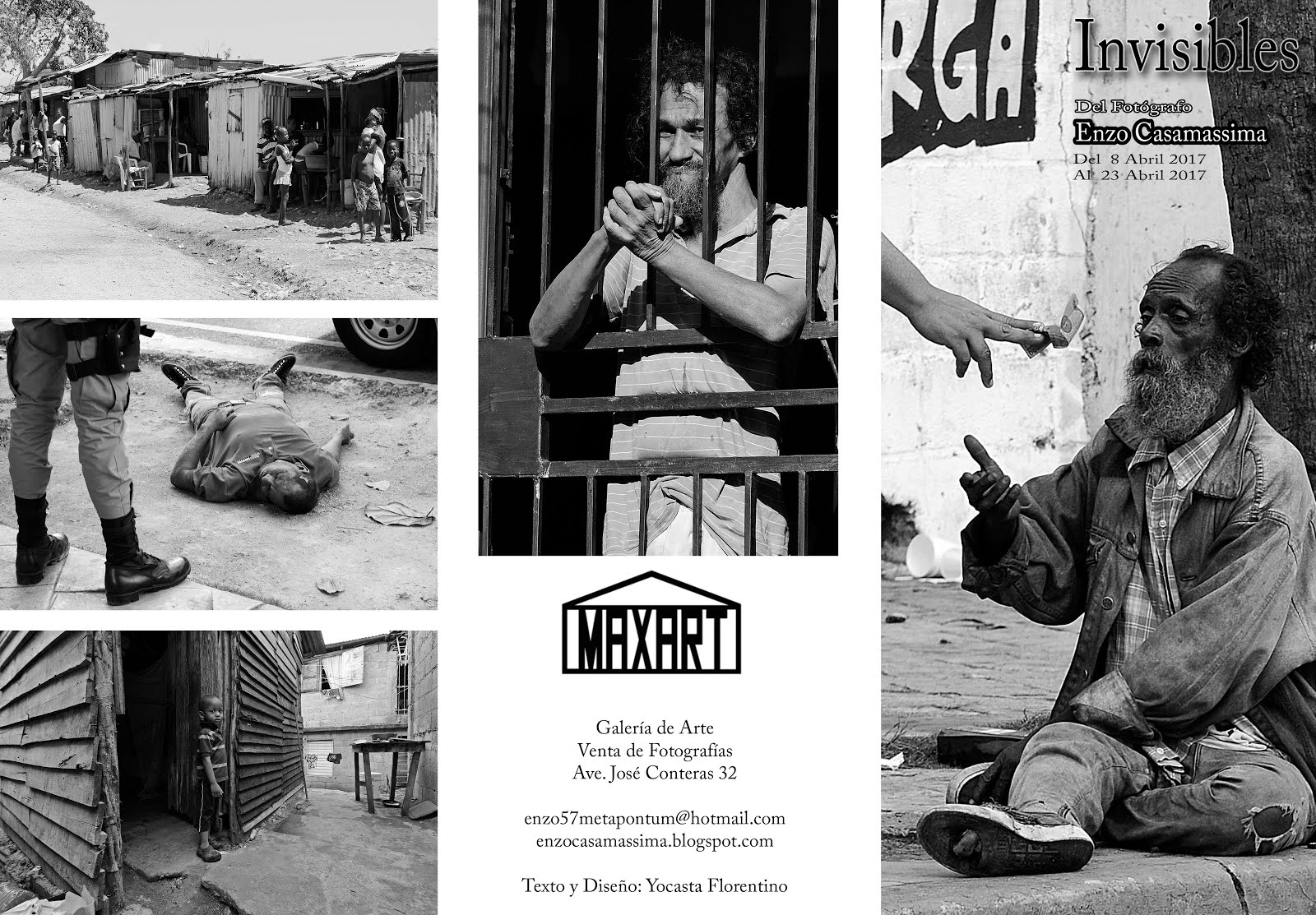LXXVIII Exposición Individual de Fotografías:
"In the City" del 11 al 26 de Diciembre,
en la Galeria de Arte, MAXART.
Vita del brigante lucano Carmine Crocco
Terza Parte
Sono
il generale di una banda brigantesca, con in testa un cappello piumato, una
tunica ingallonata, un morello puro sangue, armato sino ai denti e un esercito
di mille e duecento uomini che agiscono a ogni mio cenno. Sul far del giorno,
del 10 agosto 1861, mi avvicino verso Ruvo del Monte, situato sul pendio di una
collinetta, ombreggiata da fronzuti castagni e da ubertosi vigneti. Incontro
villette e grosse masserie. Da lontano spicca una gigantesca torre che sovrasta
il diroccato castello feudale, palesando l’antichità del villaggio. Mi fermo a
mezzo miglio dalle prime case e scrivo una lettera al Sindaco ed alla Giunta:
“Egregio Sig. Sindaco e Signori di Ruvo del Monte, sono qua non per farvi del male,
ma per pregare le SS. Ill.me che abbiano la bontà di foraggiarmi 1200 uomini e
175 cavalli, pagando in oro sonante. Poi, proseguirò il mio cammino. Spero che lor
nobili signori esaudiranno la mia preghiera e non mi obbligheranno a ricorrere
alla forza. Concedo un’ora di tempo per rispondere. Carmine Donatello Crocco.
Dopo
mezz’ora ricevo la seguente risposta: “Caro Carminuccio. Non possiamo accettare
la richiesta fattaci. Essa non solo ci compromette con il Governo, ma tocca il
cuore e il nostro amor proprio e siccome siamo ben forniti di cartucce e
vogliamo provare la nostra polvere e il nostro coraggio, aspettiamo che ti
faccia avanti con i tuoi pastorelli che ti faremo il piacere di uccidere. Il
miglior consiglio che ti possiamo fare è quello che tu vada via, poiché fra
poco arriveranno forze da Rionero, da San Fele e Calitri e sarà finita per tè e
per i tuoi. Sindaco Blasucci.”
Dopo
la lettura della lettera ai miei compagni dissi: “Giovinetti, bisogna vendicare
col sangue non solo il rifiuto, ma l’insulto di averci chiamati pastorelli. Chi
ha fegato mi segua.”
Disposi
quattro centurie sul fronte che avanzarono furibonde sul paese, accolto da un
fuoco di moschetteria ben nutrito, ma, poco diretto, mentre altri 200 uomini
ebbero ordine di attaccare di fianco. I cavalieri li lasciai a guardia sulla
strada di Rionero, con l’ordine di spingersi in avanti, per assicurarmi da ogni
arrivo di truppe. Un’altra centuria la diressi sulla strada di Calitri, con lo
stesso mandato. I rimanenti uomini agli ordini di Ninco Nanco, li lasciai
dietro per la riscossa. L’attacco fu simultaneo e terribile.
In
eterno onore di quei valorosi cittadini caduti, posso assicurare che
disputarono palmo a palmo quella loro cittadella. Perduta la prima posizione
avanzata, si appostarono sulla piazza. Cacciati anche di là, presero posizione
sul largo della chiesa e dopo aver sparato tutte le cartucce, ingaggiarono una
lotta corpo a corpo con i miei. Sopraffatti dal numero, tentarono di
raggiungere la torre, ma trovata chiusa la via, si disposero a morire, quando
le donne si buttarono piangenti fra i combattenti, implorando pietà e grazia
per i loro padri, mariti e figli. Sulla torre sventolò bandiera bianca, così la
lotta finì, ma le vie erano seminate di cadaveri, mentre i miei si davano al
saccheggio. Le autorità sedevano nel palazzo del comune ed entrando trovai i
consiglieri al loro posto. Ordinai mi fossero consegnati il ruolo della guardia
nazionale, i fucili, le munizioni dei militi, la cassa del comune e quella
della fondiaria. Mi si rispose che facessi terminare le stragi è l’incendio e
sarei stato esaudito. Cosi fu fatto. Ricordando quella giornata, io mi domando
ancora, dove quei poveri cittadini avevano potuto apprendere l’arte della
guerra che in trecento, tennero fronte per diverse ore a mille uomini, affamati
di piaceri e bottino. Quei prodi non avevano preso mai parte, né a piccole, né
a grosse manovre, anzi la ferocia del governo borbonico proibiva loro di
portare il fucile e per aver il porto d’armi dovevano pagare 5 scudi.
Perché
il Borbone non seppe utilizzare il valore e l’eroismo dei figli di questa
regione, tanto che il loro potente esercito fu messo in fuga da un pugno di
giovinetti. I garibaldini. Ho visto le infamie che si commettevano in un
quartiere militare borbonico. La frusta, il bastone e le fucilazioni sommarie e
le tremende punizioni, tanto che in noi soldati prevaleva il concetto che il
regno è tuo e dei tuoi sbirri e devi difendertelo, poiché io non morirò per la
gloria tua e per conservare sul tuo capo la corona. Ma, come mai, io che
conoscevo le infamie del Borbone, dopo la caduta di questi, mi sono rimescolato
nel fango e combattuto per una causa che aveva destato in me tanto orrore?
Poiché io avevo già le mani macchiate di sangue, la mia persona era cercata,
lottavo per vivere.
Rionero
in Vulture, 13 agosto 1861.
“Sig.
Carmine Donatello Crocco. Rendo grazie della libertà accordata ai miei
dipendenti caduti nelle vostre mani. Una seconda volta, nell’interesse del
paese, di tante famiglie e nell’interesse vostro, io vi invito a deporre le
armi e vi assicuro che non sarete fucilati e la causa vostra sarà rimessa alla
clemenza sovrana. Domani non verremo per lasciarvi tempo per riflettere. Se,
nonostante questa mia, insisterete a mostrarvi ribelle alla legge, sarò
costretto a darvi la caccia per avervi vivo o morto.”
“Signori,
a tutti ossequi. Non posso aderire alla vostra domanda, perché S. M. Vittorio
Emanuele ha rigettato l’istanza dell’avvocato Francesco Guarini e rigetterà
anche quella appoggiata dalla V. S. e siccome non voglio servire da trastullo a
chi assisterebbe alla mia fucilazione, sono pronto a vendere a caro prezzo la
vita. Ricordate che nel posto in cui mi trovo, nel 1808 fu trucidato un
reggimento di Re Gioacchino Murat. Carmine Crocco”
Crocco si acquartierò a Toppacivita, nelle
vicinanze di Calitri, dove il 14 agosto del 1861, fu attaccato dai regi
soldati, i quali subirono una netta sconfitta. Dubbioso sulle sue sorti e per
il mancato rinforzo più volte promesso dai filoborbonici, decise di
sciogliere le sue schiere, per trattare la resa con il nuovo governo. Il barone
piemontese Giulio De Rolland, nominato governatore della Lucania, era disposto
a trattare con lui. Ma, il luogotenente del re, generale Enrico Cialdini, rispose di non accordare nessuna grazia, quanto ricompensare chi rendeva
servigi. A questa notizia, Crocco tornò sui suoi passi e il 22
ottobre 1861, per ordine del generale borbonico Tommaso Clary,
incontrò il generale veterano catalano José Borjes, nel bosco
di Lagopesole, il quale, reduce dal fallito tentativo di scatenare la
reazione popolare in Calabria, voleva tentarla in Lucania, trasformando la
banda di Crocco in un esercito regolare, adottando disciplina e tattiche
militari, per assoggettare i centri minori, dar loro ordinamenti e arruolando
nuove reclute per conquistare Potenza e porre fine all’autorità sabauda in
Lucania. Crocco non ripose alcuna fiducia nei suoi intenti, anche perché arrivato
con soli 17 uomini. Inoltre era contrario alla sua strategia, ritenendo
inutili gli attacchi ai centri abitati, considerando la guerriglia, unico modo
per colpire il nuovo regime. Comunque, riconoscendo Borjes un esperto di
guerra, accettò l’alleanza, anche se i loro rapporti non furono mai armoniosi.
Poi, giunse il francese Augustin De Langlais, presentatosi come agente al
servizio dei Borbone. Augustin era un personaggio ambiguo, descritto da Borjes come
un generale che agisce da imbecille, pur partecipando a numerose scorrerie, da
buon coordinatore dei movimenti.
Crocco continuò le vecchie imprese, con inaudita
violenza, benché contava quasi sempre sul supporto popolare. Raggiunte le
sponde del fiume Basento, dopo aver reclutato nuovi militari, occupò Trivigno,
mettendo in fuga le guardie nazionali. Il popolo si aggiunse ai predoni e il
paese rapinato bruciò. La cittadinanza colta fuggì o si nasconde o morì con le armi in pugno. Caddero altri centri come Calciano, Aliano, Garaguso, Salandra
e Craco. Il 10 novembre, Carmine ottenne una netta vittoria su un gruppo
di bersaglieri e guardie nazionali, durante la battaglia di Acinello, uno dei
più importanti conflitti del brigantaggio post unitario. Poi, anche Grassano,
Vaglio, San Chirico Raparo, Guardia Perticara, furono messi al sacco, per
la loro opposizione. Crocco giunse nelle vicinanze di Potenza, il 16 novembre
1861, ma, per divergenze con Borjes, l’armata dei briganti deviò su Pietragalla. Il 19 novembre tentò l'entrata in Avigliano, paese natale del suo
luogotenente Ninco Nanco, ma il popolo unito con i borghesi, respinsero i
briganti. Il 22 novembre occuparono Bella, Balvano, Ricigliano e Castelgrande, ma
furono sconfitti a Pescopagano, lasciando 150 briganti tra morti e
feriti. Impossibilitati a sostenere altre battaglie, Crocco ordinò ai suoi
uomini, la ritirata verso i boschi di Monticchio.
Crocco ruppe i rapporti con Borjes, perché
insicuro di poter seguitare a vincere e poiché non credeva più alla promessa
del governo borbonico dell’invio di rinforzi. Il generale catalano si recò
a Roma con i suoi uomini, per fare rapporto al re e nella speranza di
riorganizzarsi con nuovi volontari e ritentare l’impresa. Ma, durante il tragitto, Borjes fu
catturato dai regi soldati, capeggiati dal maggiore Enrico
Franchini e fu fucilato con i suoi fedeli a Tagliacozzo, l’8
dicembre. De
Langlais, sparì dalla scena, poco dopo. Con la fuoriuscita dei legittimisti
stranieri, Crocco incontrò le prime difficoltà. Alcuni dei suoi uomini
iniziarono ad agire contro i suoi ordini e tutti i paesi insorti e occupati
furono riconquistati dalle autorità sabaude. I briganti e civili sospettati di
collaborazionismo furono arrestati o fucilati con esecuzioni sommarie. Carmine
continuò con azioni di mero banditismo, assalendo viandanti, compiendo
depredazioni, ricatti, sequestri, omicidi di personalità, suddividendo i suoi
uomini in piccole bande che si sarebbero riunite in caso di grandi scontri. La
tattica li rese imprendibili, favoriti dal territorio boschivo e impervio. Anche
se i tentativi erano ritenuti vani, i realisti borbonici non abbandonarono
Crocco, perché lo Stato Italiano era distratto dal completamento dello stesso. Le
sue scorrerie si spinsero sino ad Avellino, Campobasso, Foggia, Bari, Matera,
Ginosa, Castellaneta, Lecce, collaborando in diverse occasioni con altri
capobriganti come Angelantonio Masini, Eustachio Fasano e il
pugliese Sergente Romano, il quale gli propose di unire le forze e muoversi
su Brindisi, dove agiva il brigante Pizzichicchio, per occupare i
territori del barese e innalzare la bandiera borbonica. Ma, Crocco, per
le precedenti esperienze negative, lasciò cadere la proposta.
Nel marzo 1863, le bande di
Crocco comandate da Teodoro Gioseffi, Sacchetiello Coppa,
Malacarne, Caruso e Ninco Nanco, tesero un’imboscata a 25 cavalleggeri di
Saluzzo, guidati dal capitano Giacomo Bianchi, reduce della guerra di
Crimea, uccidendone 20 di loro, incluso il capitano. L’atto fu compiuto in
risposta alla fucilazione di alcuni briganti, nei pressi di Rapolla,
perpetrato dagli stessi cavalleggeri. Nell’autunno, spinto dalla crescente
pressione della coalizione regia e dal graduale abbandono del sostegno
popolare, diffuse un invito alla rivolta, cercando di sfruttare il sentimento
religioso del volgo.
“Che si aspetta? Non si commuove ancora il
cielo, non freme ancora la terra, non straripa il mare al cospetto delle
infamie commesse ogni giorno dall’iniquo usurpatore piemontese? Fuori dunque i
traditori, fuori i pezzenti, viva il bel regno di Napoli, col suo religioso
sovrano, viva il vicario di Cristo, Pio IX e i nostri ardenti fratelli
repubblicani.”
Il generale Fontana, con i capitani
Borgognini e Corona, organizzarono dei negoziati con i briganti e l’8 settembre
1863, Crocco, Caruso, Coppa e Ninco Nanco furono ospitati in una
casa di campagna, nelle vicinanze di Rionero. Durante il banchetto, Crocco
assicurò di condurre i suoi 250 uomini alla resa, chiedendo per essi un
salvacondotto. Poi, Carmine se ne andò verso Lagopesole, sventolando un
tricolore e gridando “Viva Vittorio Emanuele.” Scettico per le promesse e evitare una possibile fucilazione, non fece più ritorno e l’accordo saltò.
© 2021 by Enzo Casamassima. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission.