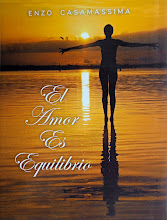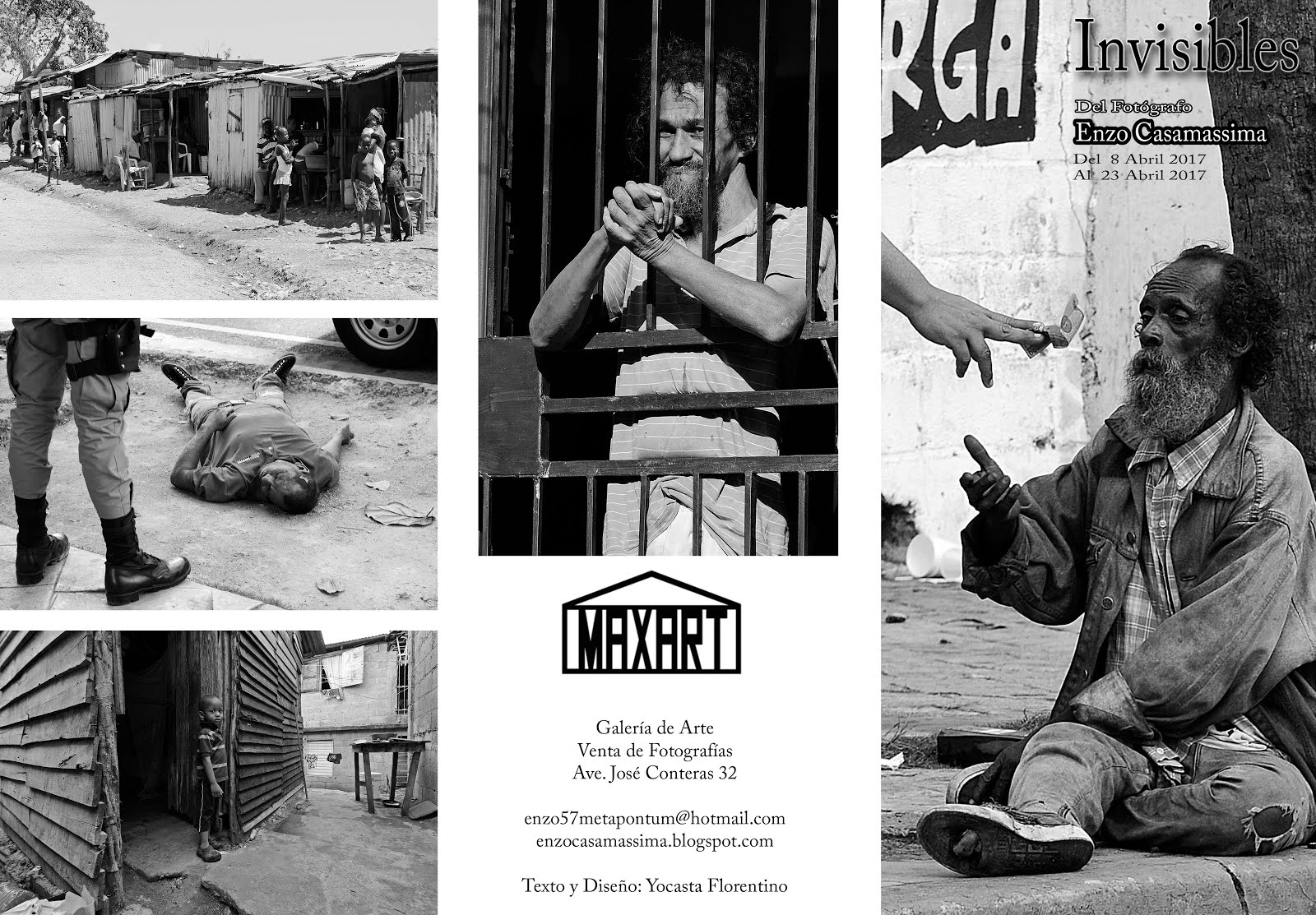LXXVI Exposición Individual de Fotografías:
"Playas y Mares V" del 9 al 24 de Octubre,
en la Galeria de Arte, MAXART.
Vita del brigante lucano Carmine Crocco
Prima Parte
Carmine Crocco, detto Donatello, soprannome
preso dal nonno paterno, Donato Crocco, nacque a Rionero in Vulture, all’epoca
parte del Regno delle Due Sicilie, il 5 giugno 1830 e morì
a Portoferraio, il 18 giugno del 1905. Suo padre Francesco, faceva il contadino
e il pastore, presso la nobile famiglia venosina di don Nicola Santangelo,
mentre sua madre, Maria Gerarda Santomauro, era una cardatrice di lana. Secondogenito di cinque figli, i suoi fratelli
furono Donato, Antonio, Marco e Rosina. Carmine ebbe una misera, ma serena
infanzia, forgiato dai racconti dello zio Martino, da cui imparò a leggere e
scrivere. Martino, ex Sergente Maggiore dell’esercito napoleonico, perse
la gamba sinistra nell’assedio di Saragozza, durante la Guerra d’Indipendenza
spagnola, per una palla di cannone. In pochi anni, da contadino, Carmine divenne
uno dei più importanti briganti dell’epoca risorgimentale, comandante di
un esercito di oltre mille uomini, fece della Lucania, l’epicentro del brigantaggio
post unitario. Su di lui pendeva una taglia di 20.000 lire.
Quando mio padre prese moglie, si divise da suo
padre, comprò alcune pecore e capre, prese in affitto un pezzo di terra da una
famiglia patrizia e cominciò a seminare grano, legumi, formentone e canapa. Con
il suo lavoro quotidiano, ricavava il fitto da pagare al padrone e provvedeva
al vitto della famiglia, mentre con le capre e le pecore, faceva fronte alle
spese di casa. Mia madre aveva ereditato un tumolo di terra, piantata a vigna,
la quale era la delizia di noi creature. Possedeva pure due casupole ed
esercitava il mestiere di scardare la lana, con cui lucrava il pane per sé e per
i figli. Sia mio padre che mia madre, che Iddio li abbia in pace, non ci facevano
mancare nulla. Bello era al mattino quando mio padre apriva l’ovile e le capre
uscivano all’aperto, saltellando per nutriti pascoli, mentre noi bambini
scorrazzando, andavamo in cerca di fiori da portare alla mamma. E mia madre,
quanta bontà nei suoi sguardi pieni di affetto, quanto amore nelle sue cure,
quanta assidua volontà di lavoro. Si alzava all’alba, preparava la bisaccia del
marito, rassettava la casa, curava i figli e poi, con faticosa lena si dava al
lavoro, sicura di poter guadagnare i suoi 40 centesimi, prima del tramonto.
Nel
1836, un bel mattino di aprile, mio fratello maggiore Donato e io, eravamo
tornati dalla scuola di Zio Martino. Pochi minuti dopo, Donato fu mandato a
raccogliere l’erba per i conigli e io a comprare del sale per la cucina. Corremmo
uno a levante e l’altro a ponente e un quarto d’ora dopo eravamo di ritorno,
avendo fatto ognuno il proprio dovere per bene, poiché al più piccolo sbaglio,
correvano schiaffi e scappellotti. Quelli della mamma, per me erano così saporiti
che qualche volta sbagliavo apposta. Venne l’ora di pranzo e seduti attorno ad
un tavolo, con un gran scodellone di minestra fumante, ci mettemmo a mangiare,
mentre la mamma dava il latte al suo figliuolo. Questo gruppo che nella miseria
era pur felice, fece invidia a Satana che volle guastarlo e per sempre. In un
altro cantuccio della stanzetta, c’era un gruppo felice di bestioline. Conigli
e galline che mangiavano l’erba portata da Donato. Inaspettatamente, un
magnifico cane levriero entrò con un salto nella nostra stanza e afferrato un
coniglio, fuggì fuori. A quella vista noi piccini cominciammo a strillare e
uscimmo fuori per togliere la preda alla bestia, ma purtroppo il coniglio non
fu lasciato che morto. Donato, armato di un randello, assestò un colpo sulla
testa del cane e il magnifico levriero cadde morto sul colpo. Disgrazia volle
che quel cane apparteneva a don Vincenzo, il quale non vedendo tornare a sé la sua
bestia, si mise a cercarla. Quando la trovò morta sul limite della nostra casa,
scagliò all’indirizzo di mia madre molti vituperi e volendo sapere chi avesse
ucciso il cane, tempestò di pugni Donato, tenendolo fermo per un braccio. Mia
madre cercava perdono, invocava pietà, ma vedendo flagellare suo figlio, posò
il piccino che aveva in braccio e si scagliò furibonda verso l’aguzzino, quando
lo scellerato le assestò un calcio nel ventre che la fece cadere per terra. Corsero
i parenti e venne il medico. Dall’aprile del 1836, al maggio 1839, dopo aver
subito un aborto, la povera donna fu costretta a letto. Chi può dire quante
lacrime spargemmo noi cinque creature, il più grande di otto anni e il più
piccolo di due. Chi avrebbe pensato più a noi? Mio padre non poteva lasciare il
lavoro, altrimenti saremmo morti di fame. Una zia ladra e ghiottona ebbe l’incarico
della casa. Lei rubava tutto ciò che le capitava sottomano e divorava quello
che trovava di buono, lasciando per noi la roba fradicia e puzzolente. Addio
scuole, addio zio Martino, parenti, compagni. Eppure abbiamo un padrone in
cielo, Iddio, un signore in terra, il Re. In quei tempi avevamo Francesco II
per Re, Maria Cristina per Regina, ma essi pensavano alle feste e alla gloria,
mentre noi morivamo di fame. Quando mia madre parve migliorare, mio padre partì
per Venosa, alla dipendenza dei signori Santangelo, per tosare le pecore e
mietere i campi di grano.
Un
mattino, Don Vincenzo si recò in campagna cavalcando un superbo morello. Era
armato come un cavaliere antico. Pistole all’arcione, fucile a bandoliera,
pugnale. Ma con tutto ciò, prima di arrivare al punto detto La Torre, a tre
miglia da Rionero, fu colpito da una fucilata che lo fece ruzzolare
insanguinato a terra. Un altro uomo vegliava su di lui e informato di quella
gita da una spia di casa, misurando luogo e tempo, ebbe agio di dar sfogo al
suo odio, quasi certo dell’impunità, poiché egli sapeva che la colpa del gesto,
non sarebbe caduta su di lui, ma su un altro che egli infamemente a mezzo di
vigliacche e false testimonianze, avrebbe indicato alla giustizia degli uomini.
Ma la mano del vile tremava, non per l’assassinio che si accingeva a compiere, quanto
per la falsa denunzia con la quale preparava la condanna d’un innocente e così,
la palla sfiorò la fronte di Don Vincenzo, portandogli via solo una ciocca di
capelli. Ma, il tentato assassinio di Don Vincenzo, doveva essere punito anche facendo
vittime innocenti. Bisognava assicurare i rei alla giustizia o almeno fare
qualche arresto, per far vedere che gli sgherri del generale Del Carretto, non
se ne stavano con le mani nella cintola. Chi credete che sia stata la prima
persona arrestata? Mio padre! Sì, proprio mio padre, il quale nell’ora del
misfatto si trovava a Venosa, in casa di Don Felice Santangelo, a nove miglia
da Rionero. Non valsero le dichiarazioni dei suoi padroni di Venosa, né le
testimonianze di ventotto persone di specchiata onestà che lavoravano con mio
padre. La causa era così evidente che nessuna testimonianza poteva distruggere
la convinzione che egli fosse il colpevole. Francesco fu posto in carcere e
sottoposto a procedimento penale. Con mio padre vennero arrestati altri cinque
poveri diavoli, carichi di numerosa famiglia, contro i quali la polizia aveva
trovato una lontana ragione a delinquere contro don Vincenzo. Ma con queste
causali ne avrebbero dovuti arrestare parecchi altri, poiché la prepotenza del
signorotto lo aveva portato a litigare con tutti i contadini del luogo, per
ragioni di passaggio, per derivazione di acque, per il pagamento dell’affitto,
per la divisione del raccolto e altri episodi. Ma, la mandante del crimine fu
una donna di Don Vincenzo.
Chi
può considerare il dolore di un uomo innocente posto in carcere, con pericolo
di cadere in mano del boia. Il reo non ha dolore, poiché la sua coscienza è
sporca. Mentre, l’innocente non sa darsi pace della libertà perduta, dell’infamia
che copre il suo nome e piange e maledice. Quando mia madre seppe dell’arresto
del marito, restò pietrificata, non volle più prender cibo e in breve smarrì la
ragione. Una volta piangeva, poco dopo rideva, ora si buttava giù dal letto,
ora tentava d’uscire sulla strada in camicia. Distruggeva tutto ciò che le
capitava nelle mani e noi, se le andavamo vicini, minacciava di strozzarci. L’unica
persona che poteva avvicinarla era suo fratello, il quale aveva una nidiata di
figli e più che pensare a mia madre, doveva zappare la terra, per dar da
mangiare alla sua famiglia. Mio padre, dal carcere di Potenza, scriveva lettere
strazianti, raccomandando parenti e amici, la moglie e i figli, ma intanto il
piccolo patrimonio spariva e la miseria s’abbatté sulla nostra casa. Il fratello
di mia madre, riunì a consiglio tutti i parenti e fu deciso che la sorella
Rosina sarebbe andata con la zia materna. Antonio in casa di uno zio paterno,
ma morì poco dopo bruciato vivo. Marco, il più piccolo, capitò sotto le unghie
della zia ladra che durante la malattia della povera mamma, si era rubato ogni
cosa. Donato andò a fare il pastorello presso un signore, come me, presso un altro
signore, in Puglia. Lontano dal mio paese, da mia madre pazza, da mio padre
carcerato, io crebbi conducendo al pascolo armenti, crebbi col veleno nel
cuore, con la rabbia nell’animo, col vivo desiderio di offendere.
Nell’anno
1845, salvai dalle acque dell’Ofanto, un certo Giovanni Aquilecchia, facoltoso
di Atella che mi ricompensò con 50 scudi. Quella somma rappresentava un tesoro
per me, avvezzo a guadagnare due lire al mese. Credendomi ricco, salutai le mie
pecore e mi recai a Rionero, assente da oltre 5 anni. Nell’animo pullulavano
tanti pensieri.
Tramite il cognato, don Pietro Ginistrelli, mio padre fu scarcerato. Su di me aveva un grande ascendente, ma non potevo
comprendere perché, da uomo gagliardo, si fosse fatto assoggettare dalle
ingiustizie sociali e avesse accettato sommesso tutti gli insulti più crudeli
che la giustizia degli uomini gli aveva infamemente gettato sul viso. Sordo
alle mie proposte di rivalsa, mi mostrava come egli fosse felice nella miseria,
cercando di calmare i miei istinti di grandezza, consigliandomi di mantenermi
modesto e lavoratore. Di comune accordo decidemmo che io sarei tornato a
Rionero, a cercar lavoro, conducendo con me la sorella Rosina. Il lavoro non mi
faceva paura, mi sentivo sano e vegeto, ero avvezzo ai disagi, per cui avrei
faticato volentieri tutto il giorno, pur di coltivare un pezzo di terreno che
fosse mio. Ma, purtroppo, io non ero nato per zappare, a me non spettava la
gioia dell’uomo onesto.
Ora
che nella solitudine del carcere penso al passato e cerco di scoprire come mai
io, nato poverissimo, col crescere della ragione, abbia voluto essere qualche
cosa, sia pure un grande infame, ne attribuisco la causa a ragioni diverse.
Prima è stata quella poca istruzione che lo zio Martino, con religiosa pazienza,
seppe impartirmi. E come nel regno dei ciechi, il sguercio è considerato
signore, così io, mescolato fra tanta plebe rozza e analfabeta, io che sapevo
scrivere e che facevo versi all’innamorata, mi sentii sommamente a loro
superiore. La vita nomade condotta da ragazzo, contribuì a sviluppare in me, il
germe della grandezza. Girando per le fiere di Bari, Barletta, Andria,
Altamura, Foggia, Gravina, avevo appreso che la vita non era racchiusa tra i
confini del Vulture e le boscaglie di Monticchio. Nei contratti di vendita che
si stipulavano, vedevo le monete d’oro correre di mano in mano e i miei padroni
aumentare il loro patrimonio, standosene seduti nelle loro ville. Pensavo al
perché fosse a loro riservata tanta fortuna, mentre noi dovevamo
lavorare. Aggiungi un animo ulcerato dalle sventure di famiglia e non sarà
difficile renderti conto, come mi resi celebre, non per virtù e bene, ma per
infamia e male.
© 2021 by Enzo Casamassima. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission.