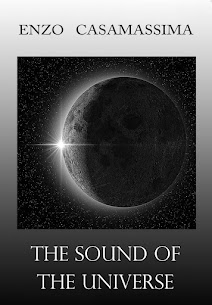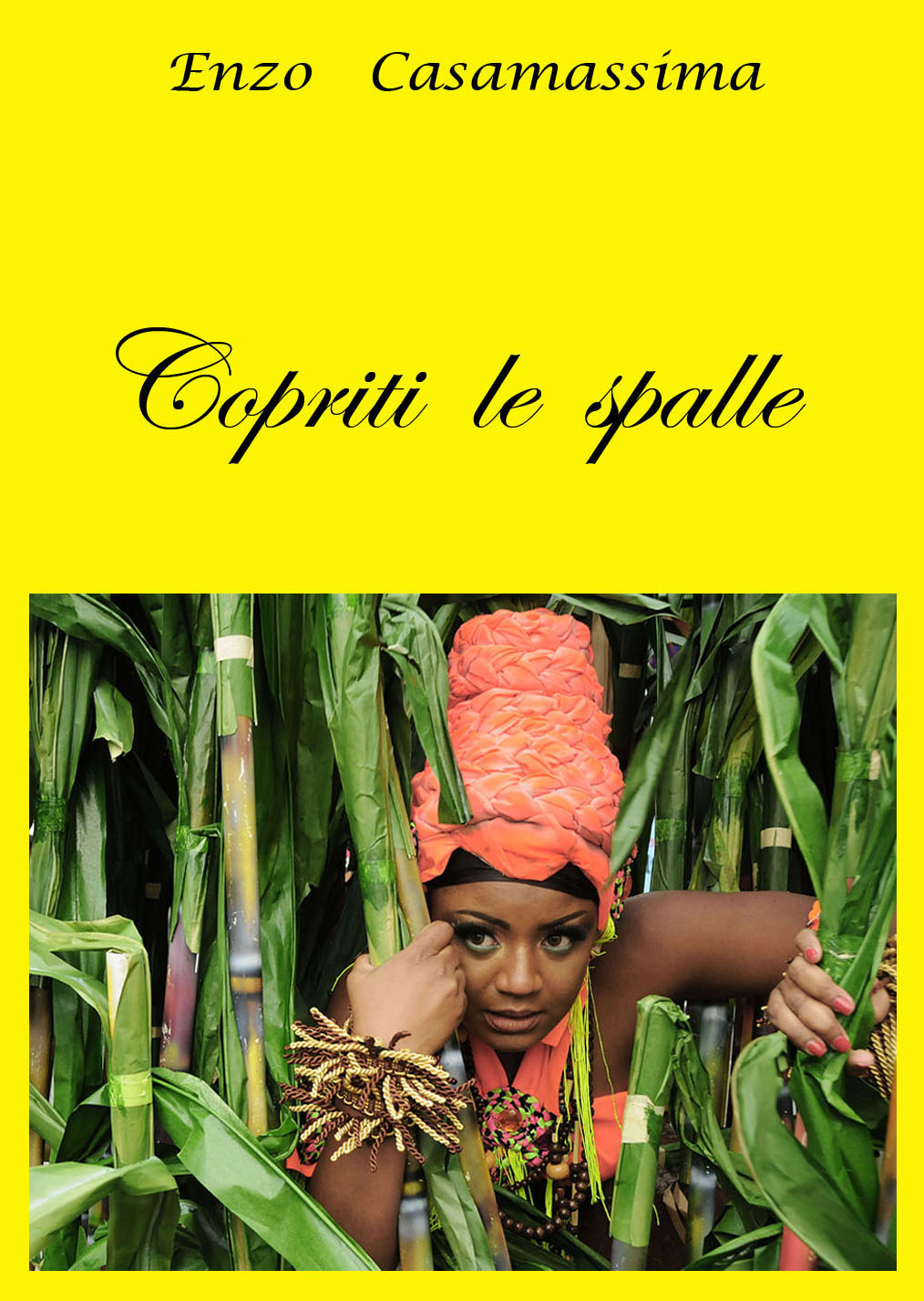Per una corretta visone del blog si consiglia di usare il computer. Con gli altri dispositivi la visione è imprecisa.
Para una correcta visión del blog se recomienda usar la computadora. Con otros dispositivos la visión es imprecisa.
CXX Exposición Individual de Fotografías: "Ninos V" del 7 al 22 de Junio, en la Galeria de Arte, MAXART.
Niccolò
Paganini
Niccolò Paganini nacque a Genova, il 27 ottobre del 1782 e morì a Nizza, il
27 maggio del 1840. Fu violinista e compositore tra i più importanti di tutti i tempi, per la padronanza dello strumento e per
le innovazioni, in particolare per lo staccato e il pizzicato.
Niccolò Paganini nacque da una modesta
famiglia di Carro, provincia di La Spezia. Il padre gli impartì le prime
lezioni di mandolino, per poi, indirizzarlo allo studio del violino,
ricevendo solo una trentina di lezioni da due maestri del suo tempo e a 12 anni
già si esibiva nelle chiese di Genova.
Nel febbraio del 1796, gli fu
diagnosticata un’encefalite morbillosa,
con crisi catalettiche, tanto che in alcune occasioni fu creduto morto. La
malattia gli lascerà segni indelebili sul sistema nervoso, sempre più evidenti
in età matura. Nello stesso anno si ammalò di polmonite.
Niccolò studiava dieci ore al giorno, su un
Guarneri regalatogli da un suo ammiratore. Si ritiene che lo strumento sia
stato il Guarneri del Gesù, Carrodus, del 1743, in seguito dallo stesso perso
al gioco. Poi, rientrò in possesso dello strumento nel 1800, a Livorno, quando era
in possesso di un altro Guarneri del Gesù, Cannone, anch’esso del 1743. Da
recenti studi sulle fibre del legno di ambedue gli strumenti, il Carrodus e il
Cannone risultano essere gemelli, poiché ambedue fabbricati con il legno del
medesimo albero.
Nel 1801, a 19 anni, interruppe l’attività
concertistica per dedicarsi all'agricoltura e allo studio della chitarra.
In breve divenne un virtuoso anche di quello strumento, scrivendo molte sonate.
Paganini percorse l’Italia per ben tre volte, recandosi anche nelle principali città
europee, per i suoi acclamati concerti, ovunque mietendo successi.
Niccolò Paganini, il più grande violinista di
tutti i tempi, era dotato di una tecnica straordinaria e le sue composizioni
erano considerate ineseguibili da altri. Compiva salti melodici di diverse
ottave ed eseguiva lunghi passi con accordi su quattro corde, alla massima
velocità. Alternava note eseguite con l’arco e note pizzicate alla mano
sinistra. Eseguiva anche misteriosi e spettrali giri armonici.
Paganini aveva dita molto lunghe e mobili,
come mostrano i calchi delle sue mani fatti il giorno della morte che lo
aiutarono a toccare livelli di esecuzione insuperati. Con l'estenuante
esercizio quotidiano e una enorme
falcata delle dita, procurata dalla sindrome di Marfan, poteva avvolgere
la tastiera del violino con rapidità e interezza.
Per mostrare le sue doti di violinista,
Paganini aveva l'abitudine di incidere le corde del violino che utilizzava
durante i concerti, in modo che le sue violente esecuzioni ne provocassero la
rottura, fino al punto da restare con una sola corda, quella del sol. Che la
quarta corda fosse lasciata integra non era casuale. Il sol è la corda più
espressiva del violino che permette di passare dal grave all'acuto in modo
morbido, senza le corde del mi, la e re. Paganini univa la spettacolarità
dell'esecuzione, al dinamismo, galvanizzando le folle. Modificava anche
l'accordatura sfumando i suoni e utilizzando la tecnica del pizzicato con la
mano sinistra che all’epoca si usava solo in Italia, da pochissimi.
Oltre al virtuosismo, a determinare il suo
successo era anche il forte alone di mistero che circondava la sua persona. Si
diceva che fosse stato incarcerato per aver ucciso un rivale in amore; che in
prigione gli fosse stato concesso di suonare il violino; che con il passare del
tempo avesse perso tutte le corde tranne quella di sol, ritrovandosi a suonare solo
su quella corda. La serie di accordi di difficile impostazione sono
dovuti anche al fatto che Paganini voleva essere l'unico in grado di suonare la
propria musica, in modo da essere l'unico a potervi lucrare. Volendo mantenere
segrete le partiture, nei suoi concerti le consegnava al direttore d'orchestra
solo qualche ora prima dell'esecuzione.
Suonando in maniera ineguagliabile, si
diceva che avesse stipulato un patto con il diavolo. Queste credenze, oltre al
suo straordinario virtuosismo, erano alimentate dalla sua magrezza, dovuta
alla sifilide. Vestiva di nero, il viso era scarno e gli occhi rientrati
nelle orbite; aveva perso la dentatura per le cure al mercurio che servivano a
curarlo dalla sifilide; per la mancanza dei denti la bocca rientrava, mentre
naso e mento si erano avvicinati.
Nel 1834, iniziano i sintomi di una
malattia polmonare, segnata da colpi di tosse che duravano anche un'ora,
impedendogli di esibirsi. Furono interpellati molti medici, ma nessuno riuscì a
curarlo. Il dottor Sito Borda, di Pavia, pose la diagnosi di TBC,
curandolo con latte di asina. Poi, propose medicamenti mercuriali che davano
grossi effetti collaterali.
In seguito, insorse una laringite, con
necrosi dell'osso mascellare. Malgrado non avesse una buona opinione dei
medici, ne cercava sempre di nuovi, nella speranza di trovarne uno che potesse
curarlo. Per gli sforzi della tosse diventò afono. Gli faceva da interprete il
figlio Achille, di 15 anni che gli leggeva le parole sulle labbra. Quando
questo non fu più possibile, scriveva dei bigliettini. Nonostante le difficoltà
non si abbandonò alla sconforto, dimostrando una grande forza d’animo.
Paganini morì a cinquantasette anni, a
Nizza, in casa del presidente del Senato. Il vescovo ne vietò la sepoltura
in terra consacrata, per la sua fama di eretico. Il suo corpo fu imbalsamato e conservato nella cantina della
casa dov’era morto. Dopo vari spostamenti, nel 1853, fu sepolto a Parma.
Achille, diventato adulto, pubblicò le sue
opere e in seguito i nipoti che non lo avevano conosciuto, venuti in possesso
dell’intera opera, decisero di venderla allo Stato. Dopo il rifiuto, misero
l'intera opera all'asta.
Il detto, Paganini non ripete, ebbe origine
nel febbraio del 1818, a Torino, quando Carlo Felice, futuro sovrano della Savoia,
dopo aver assistito a un suo concerto, lo pregò di ripetere un brano. Per le
lesioni ai polpastrelli e per le improvvisazioni, rendendo le esecuzioni
irripetibili, disse: “Paganini non ripete.”
“Ho pianto solo due volte in vita mia: quando un tacchino farcito di
tartufi mi cadde nell’acqua e quando sentii suonare Niccolò Paganini.”
Gioacchino Rossini.
2025 by Enzo Casamassima. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission.