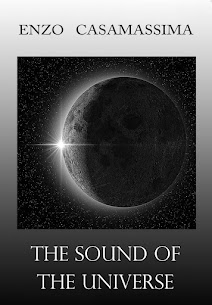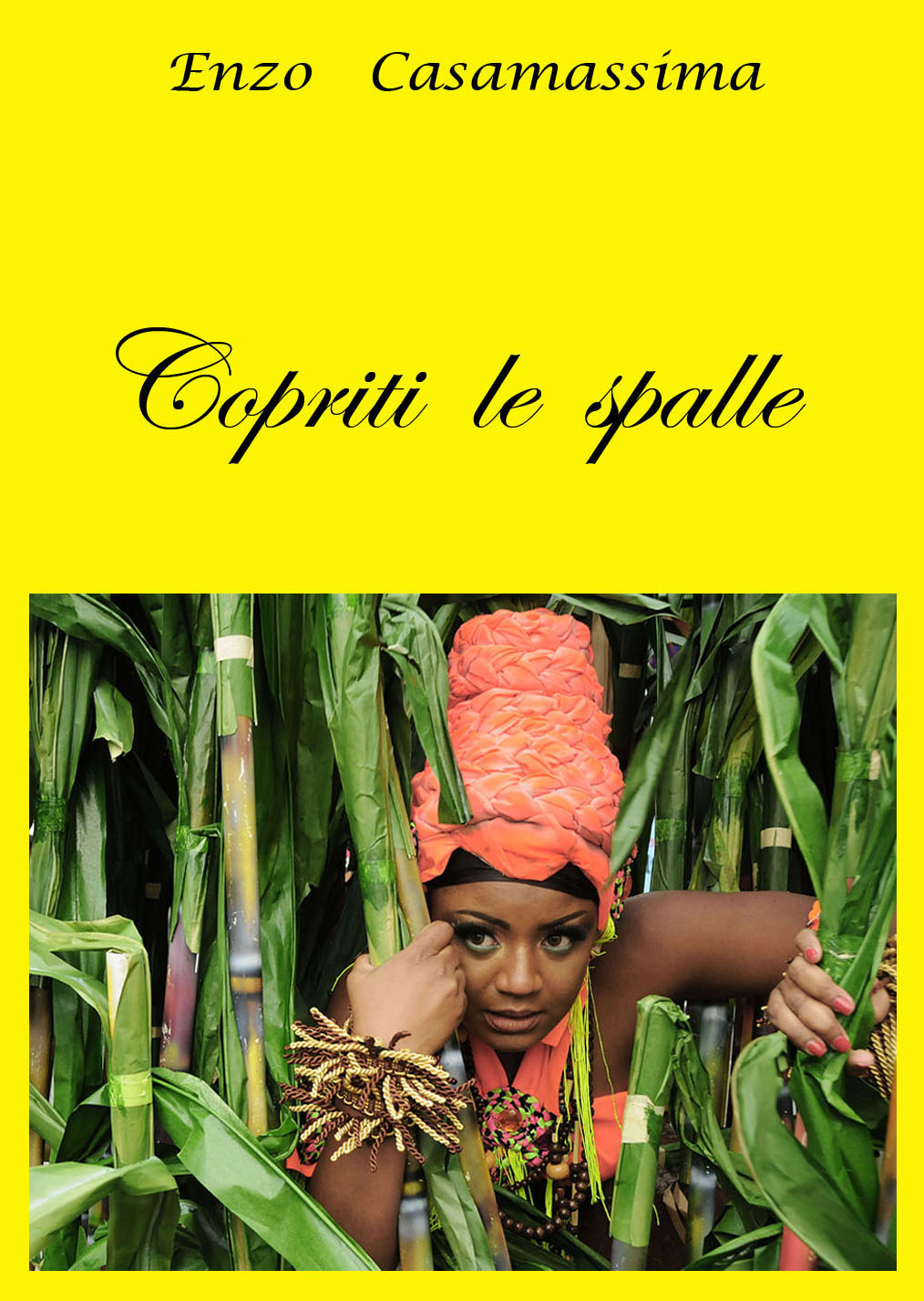Per una corretta visone del blog si consiglia di usare il computer. Con gli altri dispositivi la visione è imprecisa.
Para una correcta visión del blog se recomienda usar la computadora. Con otros dispositivos la visión es imprecisa.
CXIX Exposición Individual de Fotografías: "Pesca II" del 10 al 25 de Mayo, en la Galeria de Arte, MAXART.
Le Romane
Nella civiltà Romana, in presenza di malformazioni
congenite, il tasso di abbandono delle neonate era alto, ma quando le bambine
venivano riconosciute dal padre entravano a far parte della sua gens. Le bambine nate in famiglie agiate erano
educate in casa, imparando a leggere, a scrivere e a far di conto. La madre e
le ancelle le iniziavano alle faccende femminili, preparandole a diventare
spose e madri. Le bambine nate nella famiglie umili imparavano un mestiere.
Nell’antica Roma, poche coppie si sposavano per amore, poiché il matrimonio era
un’istituzione societaria atta alla procreazione dei figli che avrebbero dovuto
ereditare e facilitare la vita del
gruppo familiare tramite alleanze, accrescendo il potere politico, sociale ed economico. Quindi, in tutti i matrimoni, in seguito arrivava l’amante.
A Roma, gli scapoli dovevano pagare delle tasse più esose degli ammogliati,
quindi era più conveniente sposarsi.
Nella Roma
arcaica la donna era sottomessa alla potestà del padre, pater familias, il quale poteva venderla come schiava e se
rubava il vino dalla botte poteva anche ucciderla. Le figlie si sottraevano
alla patria potestà diventando proprietà del marito, quando si sposavano cum
manu, mentre sine manu, restavano di proprietà del padre. Da vedove diventavano
proprietà del figlio maggiore. Queste regole, nel trascorrere dei secoli s’ammorbidirono,
limitate dalla pietas familiare.
Il matrimonio cum manu,
si divideva a sua volta in tre forme. Confarreatio,
coemptio y usum. La confarreatio era la forma più antica e solenne del
matrimonio, celebrato in presenza di dieci testimoni, i quali, insieme agli
sposi si coprivano la testa con una pelle di pecora, offerta in sacrificio.
Poi, lo sposo prendeva sale e panis farreus,
giurando d’amare la sposa. Ottaviano Augusto e Livia Drusilla scelsero questa
maniera per sposarsi. La coemptio era celebrata consegnando al padre della
sposa una moneta d’argento e una di bronzo. Il matrimonio per usum si celebrava
dopo che la sposa aveva vissuto con lo sposo un anno. Per divorziare bastava
che la sposa dormisse fuori casa per almeno tre notti. La formula cum
manu passò in disuso alla fine della Repubblica, cedendo il passo a quella sine
manu, dove la donna rimanendo sotto la tutela paterna, riceveva la sua eredità,
restandone in possesso anche in caso di divorzio.
Dopo
il 445 a.C., con la lex Canuleia, i plebei potevano sposare un patrizio. La
sposa doveva avere un’età minima di dodici anni e lo sposo quattordici. I padri
potevano fare una promessa matrimoniale quando la bambina aveva sette anni.
Sposarsi quando una ragazzina non aveva ancora completato lo sviluppo fisico,
implicò la morte di molte ragazze per complicanze da parto. Il matrimonio con
figli anche se adottati non era lecito e neppure tra fratelli. Neanche lo zio
poteva sposare la nipote, anche se all’epoca di Claudio, il senato fece
un’eccezione, permettendo allo stesso di sposare, nel 49, sua nipote Agrippina
Minore. Le plebee, non possedendo una dote, si sposavano in ritardo. Anche se non era proibito, non era
consigliabile sposarsi nei giorni festivi, perché gli invitati non avrebbero
partecipato alla cerimonia, preferendo le feste religiose; quindi le vedove o
chi non voleva l’attenzione della gente celebravano il matrimonio in quei
giorni.
La sposa vestiva la tunica correcta, bianca e ben
stirata, corredata da una cintura, cingulum, con il nudus hercules che doveva
essere sciolto dallo sposo a notte. I suoi capelli erano divisi in sei trecce,
coperte da un velo color arancio, il flammeum, con in testa una corona. Le
scarpe erano dello stesso colore del velo. La casa era decorata con rami di
alberi contenenti foglie e fiori. La sposa univa la sua mano a quella dello
sposo, recitando una frase di conferma della cerimonia. Dopo il rito si
festeggiava con i famigliari e gli amici, in un fastoso banchetto. Alla fine si
simulava il ratto della sposa da parte dello sposo, la deductio, che consisteva
nel prendere la sposa, rifugiata nelle braccia della madre, con lacrime e
lamenti, dando inizio al corteo nuziale. Le persone andavano al grido di Talassio,
in riferimento all’episodio avvenuto durante il ratto delle Sabine. Davanti
casa lo sposo prendeva la sposa in braccio per varcare l’uscio. In quest’ultimo
atto non bisognava inciampare altrimenti il malaugurio avrebbe regnato su di
loro. Il giorno dopo la sposa offriva un alimento a Lares e Penates e un
banchetto per i familiari più stretti.
Nella Roma antica non esisteva il divorzio, ma il marito
poteva ripudiare la moglie e rispedirla dal padre, con discredito per la
famiglia. Solo il marito
poteva chiedere il divorzio e per quattro motivi. Nel caso in cui lei lo avesse
tradito, se si fosse ubriacata, se avesse abortito contro la volontà del marito
o se si fosse data alla stregoneria. Il
primo divorzio della storia Romana che si ricordi, si ebbe per sterilità, tra
Spurius Carvilius Ruga e sua moglie. Nella Roma Repubblicana bastava la volontà di uno dei due suoceri a
sciogliere il matrimonio, anche contro la volontà dei due giovani.
Nell’epoca imperiale ci aggregarono altri motivi per divorziare,
come avvenne a Caio Sulpicio Gallo che ripudiò la moglie perché seppe che era
uscita a capo scoperto. Quinto Antistio Veto divorziò dalla moglie perché l’aveva
vista parlare con una liberta di dubbi costumi. Publio Sempronio Sofo divorziò
perché la moglie aveva assistito ai giochi, senza avvisare il marito. Con il
passo del tempo, i divorzi aumentarono a dismisura, per la voglia di allacciare
nuove alleanze tra famiglie più importanti. Nelle famiglie imperiali, tra il 27
a.C. e il 96, i divorzi furono ventisette. Alla fine del I secolo a.C., le
mogli potevano gestire i propri averi e risposarsi in caso di divorzio o di vedovanza. Si
divorziava in pochi minuti, senza formalità
giuridiche. I vedovi
potevano sposarsi subito, mentre le donne dovevano aspettare un anno, per tema
di gravidanze occulte.
All’epoca
di Augusto, Roma stava soffrendo un declino demografico soprattutto nella
classe aristocratica, perché le coppie avevano deciso scientemente di ridurre
il numero della prole, per problemi contingenti alla procreazione e
all’allevamento. In più, ci fu una diminuzione della fecondità, dovuto alla
presenza di piombo nelle tubazioni dell’acqua potabile e molte donne
preferivano rimanere con il padre che sapeva essere più dolce di un marito.
Augusto decise di invertire la tendenza, divulgando due leggi che imponevano
alla gente di procreare, pena un forte tributo da versare all’erario. La lex
maritandis ordinibus, del 18 a.C. e la lex Poppaea del 9 a.C., obbligavano gli
uomini aristocratici tra i 25 e i 60 anni e tutte le donne tra i 20 e i 50
anni, di sposarsi, altrimenti avrebbero perso l’eredità. Stabilì inoltre che
tutti i padri con tre o più figli potevano entrare nella magistratura prima
dell’epoca prevista, tramite la legge, ius trium leberorum e le donne potevano
ereditare e gestire i propri beni senza interferenze maritali, con la ius trium liberorum, ma le misure non
sortirono l’effetto desiderato.
Concubina era quella donna che aveva una relazione sessuale
con un uomo sposato, vivendo in casa di quest’ultimo, senza essere sua moglie.
Il nome concubina viene da cum e cumbo, ossia, giaccio insieme. Dalle origini,
la poliginia era una prassi e oltre alla moglie, anche nei ceti più bassi, un
uomo ospitava nella sua casa, una o più donne. Una legge emanata da Numa
Pompilio stabiliva che la moglie legittima stesse un gradino più in su,
rispetto alle altre paelices, concubine, presenti in casa.
Vi erano due tipi di concubinaggio. Affiancare la
concubina a un uomo già sposato o diventare la sua unica donna, senza sposarsi.
Molti senatori di età avanzata, vedovi o divorziati con figli, preferivano una
concubina a una nuova moglie. Avrebbero salvaguardato il patrimonio di famiglia
ed evitato problemi di successione, qualora fossero nati nuovi figli, i quali
non avevano diritti. Qualsiasi genere di contatto tra uomini e donne, in
pubblico, era considerato amorale e una coppia, pur sposata, non poteva neanche
tenersi per mano.
Chiunque toccasse una donna in maniera intenzionale, chi
le indirizzava epiteti offensivi, chi le faceva proposte indecenti, pressioni
psicologiche o la pedinava, era punito da un’apposita legge. Lecito era avvicinare
una donna, ma se era una matrona d’alto rango e la si corteggiava in modo
volgare o insistente, si era condannati a delle pene pecuniarie che aumentavano
con lo status della donna. Le strade di Roma erano pericolose per loro,
soprattutto se indossavano gioielli, poiché per un povero, un tale furto valeva
una vita di lavoro. Le matrone uscivano raramente di casa e sempre a capo scortato.
Portavano seco un fazzoletto per scongiurare il sudore e la polvere e un
ventaglio, flabellum, per combattere il caldo e scacciare le mosche, oltre a un
piccolo ombrello, umbraculum. L’ombrello, già usato dagli Etruschi, era molto
simile a quelli di bambù, oggi usato
in estremo Oriente e nell’Europa fino XIX secolo.
Giovenale delle donne diceva: “Oggi,
nell’alta società, l’unico buon affare è una moglie sterile. Tutti ti saranno
amici, sperando nel tuo testamento. Quella che ti fa un figlio, chi ti dice che
non metta alla luce un negro?”
Il matrimonio era diventato
un impiccio da evitare. L’infanticidio era vietato, ma l’aborto era praticato,
altrimenti i neonati si abbandonavano ai piedi della colonna lattaria e ripresi
da nutrici stipendiate dallo Stato,
per allattare i trovatelli. In epoche antecedenti, il matrimonio era stato un
sacramento e allevare i figli era considerato un dovere verso lo Stato e gli
dei, i quali promettevano la vita eterna solo a chi procreava. Poi, la società
Romana cambiò e tutti mischiarono il sangue Romano con quello di altre etnie
dell’impero; Siriani, Ebrei, Egiziani, Greci e altri.
Le
donne hanno dovuto combattere per vedere rispettati i propri diritti, ma in
confronto ad altri popoli non furono trattate male. La società, pur maschilista, aveva grande considerazione
delle donne, le quali erano chiamate
a svolgere compiti secondo la volontà dei mariti, spesso lontani dalla patria,
amministrando le finanze, la casa e i figli. Escluse dalla vita politica, non
potevano votare, non potevano decidere chi sposare e non stilavano un
testamento, ma potevano amministrare i propri beni e avere parità morale,
sociale e giuridica. La donna Romana viveva un contesto migliore di quella Ateniese,
dove era un oggetto nelle mani
dell’uomo, mentre la donna Romana si confrontava quasi alla pari. Non potevano interferire nella
vita politica, ma in realtà, tante donne hanno controllato tanti illustri
uomini. Cornelia, la madre dei Gracchi è il prototipo della donna che i Romani
sognavano. Moglie fedele, anche dopo la morte del marito e madre
irreprensibile. Lucrezia, donna onesta e pudica, al tempo di Tarquinio il
Superbo, preferisce affrontare il suicidio, anziché il disonore. Ottavia,
sorella di Ottaviano e sposa di Marco Antonio è l’esempio di madre e moglie
virtuosa, con doti fisiche e intellettuali elevate, prototipo di donna raffinata;
devota alla famiglia, a scapito delle proprie necessità.
Ortensia, donna evoluta, tenne nel 42 a.C., un
discorso pubblico a causa di un provvedimento fiscale verso le matrone più
facoltose, le quali avrebbero dovuto versare un cospicuo contributo allo Stato,
in base al loro patrimonio, riuscendo a far diminuire il numero delle donne
costrette a farlo. Nel 195 a.C., protestarono
per molti giorni, per far abrogare una legge ritenuta restrittiva che imponeva
di non indossare vestiti dalle tinte vivaci, di non possedere più di mezza
oncia d’oro e di non salire sui carri in città, tranne nelle cerimonie
religiose. Furono così tante che la famigerata Lex Oppia fu abrogata.
La domina, la signora, mangiava seduta accanto al marito sul triclinio,
mentre lui era disteso. Nella casa si limitava a dirigere e sorvegliare il
lavoro degli schiavi. Talvolta si dedicava a tessere la lana per gli abiti del
marito e dei figli. Le visite nella casa, domus, erano rare e si risolvevano
rapidamente. Con l’avvento del
Cristianesimo, le donne dovevano essere ignoranti per essere asservite più facilmente.
Furono bruciati i libri, ma soprattutto i loro scritti. Le opere della poetessa
Sulpicia, si salvarono perché furono ritenuti scritti dal poeta Tibullo. La
Chiesa non dichiarò che la donna aveva un’anima. Alla caduta dell’Impero Romano
e all’avvento della Chiesa, il riconoscimento dei loro diritti fu eliminato con
metodi brutali.
La
domina, sposa o figlia di un facoltoso, si truccava come fanno le donne dei
nostri tempi. L’operazione era un rito che poteva durare anche delle ore, realizzato
con l’ausilio di tre schiave. Tinta di calamari per disegnare gli occhi, cenere
per le ciglia, polveri rossastre per le gote, minio e cinabri per tingersi le
unghie delle mani e dei piedi, per le più abbienti polvere d’oro attorno ai
capezzoli, se si prevedeva un finale felice. Gli ingredienti erano elaborati in
creme a base di miele, per dare luminosità al viso e mantenere le pelli morbide.
Le donne
Romane consideravano seducente l’unione delle sopracciglia. Chi non le aveva, se
le procurava, triturando e mischiando uova di formiche con mosche secche. Per profumare la sua signora, la schiava si
riempiva la bocca di profumo, nebulizzandolo sulla parte da profumare. Una
sorta di spray ante litteram.
Le Romane
si tingevano i capelli di biondo, con erbe teutoniche e usavano spumeggianti
parrucche bionde, rosse o nere. Poi,
oltre ai colori tradizionali, fu usato anche il verde e l’azzurro, soprattutto
dalle prostitute di lusso, ma anche dalle donne più libere. Per la cura dei
capelli erano usate varie misture con aceto e tuorlo d’uovo, alternato con
mele, fiori d’iris e latte. Ovidio, nella sua opera Ars Amandi, consigliava che
ogni donna scegliesse davanti allo specchio la pettinatura che più le donava.
Un volto lungo vuole capelli divisi sulla testa, mentre per un viso tondo è
meglio che i capelli siano raccolti a nodo sopra il capo, con le orecchie
scoperte o sciolti sulle spalle. C’erano pettinature con capelli inanellati,
stretti alle tempie, sciolti in grandi onde o finta trascurata che richiedeva
più cure di tutte. La canizie si mascherava con una tintura. Le Romane usavano
legare i capelli a coda, annodati o intrecciati dietro le spalle, a boccoli
sulle spalle, annodati a corona sul capo o raccolti in reticelle o cuffie. In
epoca Flavia, le donne si fecero acconciare i capelli in complicati riccioli o
lunghe trecce disposte come torri sulla testa che le slanciavano, aiutate dalle
ornatrices, schiave specializzate. Diademi, coroncine o spilloni completavano
le acconciature. Alcune donne praticavano la
chirurgia estetica per migliorare alcuni difetti estetici eclatanti, come un
gozzo preminente o il labbro leporino.
Nell’epoca
repubblicana, in strada le donne sposate indossavano un copricapo chiamato rica,
mentre in età imperiale andavano a capo coperto. Le matrone non indossavano
veri e propri cappelli, ma ponevano sul capo un lembo del mantello in nome
della loro serietà, adornando le chiome con dei nastri a diverse altezze, su una
pettinatura raccolta dietro o a ricci sciolti sul davanti, multicolori. I
nastri erano di bisso, di seta, dorati, tempestati di paste vitree o con perle
o gemme. Livia Augusta portava un grosso boccolo sulla fronte, poche onde sui
lati e trecce raccolte dietro la nuca. Pur senza brillare per raffinatezza, essendo
l’augusta, dettava la sua semplice moda ordinata dal marito. Poi, alla morte di
Augusto le donne si diedero alla pazza gioia. La pettinatura di Giulia Drusilla
era un capolavoro di spregiudicatezza. Dietro il capo aveva una treccia che
tornava indietro raccolta da un fermaglio. Intorno al viso i capelli ondulati,
con una fascia di metallo che li ornava e li fermava. Degli anellini spuntavano
dalla capigliatura sul viso, ornato fin davanti alle orecchie. Poppea usava
pettinature elaborate fatte di boccoli sulle spalle e riccioli sulla fronte,
diademi e nastri. Molto diffuso era tingersi
le labbra di rosso.
Le donne
dell’alta società si vestivano quasi tutte allo stesso modo e i loro indumenti
non erano molto dissimili da quelli maschili. Il sarto arrivava a casa,
vestitor, il quale provvedeva al loro guardaroba. Una morbida stoffa chiamata
strophium, avvolgeva il seno, per metterlo in risalto e mutandine eleganti e
sexy, ricamate con arabeschi di fiorellini, simili agli attuali tanga,
adornavano le parti intime.
Poi,
indossavano una tunica simile a quella dell’uomo, chiamata stolae, sormontata
da uno scialle chiamato palla che arrivava sino al ginocchio. Sopra la tunica, subucula, indossava una tunica più corta, supparum o
un’ampia stola che arrivava sino ai piedi. Tutti gli indumenti erano fissati in
varie parti tramite delle cinture, cingula, cinture piccole, subcingula,
spille, fibulae, per dare grazia al vestito. Gli abiti erano colorati e
adornati con gioielli e accessori colorati, abbinati elegantemente. La dalmatica era un abito in lino che poteva essere corto
o lungo, con ampie maniche. Oggi costerebbe dai 500 ai 3.000 euro. Se la
dalmatica era in seta, con strisce di porpora scura, poteva costare sino a
13.000 euro. In momenti particolari usavano le plucca, scarpe alte che
servivano a slanciarle.
La discriminazione trai due sessi, si
verificavano anche al momento della identificazione. Mentre i maschi avevano
tre nomi, praenomen, nomen gentilizio e il cognomen, le donne avevano un solo
nome che si riferiva a quello gentilizio. Quello di Cornelia, la famosa madre
dei Gracchi, è un nomen che indica solo la gens Cornelia. da qui gli aggettivi
che bisognava inserire per distinguere una donna da un’altra della stessa
famiglia; maggiore, minore, seconda, terza e cosi discorrendo. Oppure si
menzionava il nome del padre; Annia, figlia del senatore Publio Annio. Era
anche in voga usare un diminutivo del nome paterno; Livia Drusilla, moglie di
Ottaviano Augusto, il padre si chiamava Druso. Solo in età imperiale, le donne
si potevano indicare aggiungendo al nomen, il femminile del cognomen del padre
o del marito, come Cecilia Metella.
Ma, sicuramente, il praenomen delle donne è
sempre esistito, ma noto solo ai parenti stretti e vietato comunicarlo ad
altri. Si tratterebbe di una usanza Sabina, presa agli albori della storia di
Roma e poi fatta propria. I Sabini consideravano il praenomen un elemento
troppo intimo di una donna, quindi da dover nascondere come il corpo. Infatti,
le prostitute si facevano chiamare solo con un praenomen. Da qui, l’usanza
ancora in voga, di non chiamare le persone per nome, quando vi è una concreta
differenza di età, di cultura, di appartenenza, di status.
Alcune matrone
pagavano somme esorbitanti per passare una notte di piacere con un gladiatore e
alcune ponevano come condicio sine qua non che arrivassero sporchi e
sanguinanti dopo il combattimento. Anche alla moglie dell’imperatore Marco Aurelio, Faustina Minore, piacevano
i gladiatori. Mentre il marito era lontano, lei si trasferiva a Gaeta, dove
c’era una grande scuola gladiatoria, togliendosi tutti gli sfizi. Durante una
nottata di piacere rimase incinta di Commodo, il quale, da imperatore, combatteva
nell’arena. Eppia, moglie di un senatore, amava un gladiatore chiamato
Sergiolus, piccolo Sergio. Giovenale lo descrive con la faccia sfregiata, una
gibbosità sul naso per colpa dell’attrito con l’elmo e un occhio lacrimante. Una specie di mostro,
eppure per lui, abbandonò una vita agiata, il marito senatore e i figli,
seguendolo in Egitto.
A Roma, si andava a letto presto e ci si svegliava all’alba.
In epoca imperiale, tra le famiglie aristocratiche, si diffuse l’abitudine di
dormire in stanze separate. Pur essendo stata la civiltà più legata all’igiene,
al mattino nessuno si lavava. Chi lo faceva era aiutato da uno schiavo che
sorreggeva un catino pieno d’acqua. I Romani si lavavano nelle terme, dopo
l’ora di pranzo, ma il sapone era sconosciuto. Nel bagno pubblico, per lavare le parti
intime, si usava una spugna imbevuta con acqua e sale. I Romani si lavavano i
denti con l’orina e quella spagnola era la più quotata, infatti era
imbottigliata e venduta in tutto l’impero.
Il bacio per i Romani era di tre tipi. Il bacio con le
labbra chiuse si chiamava Osculum, da dare al marito alla presenza di estranei
o in casa, in osservanza dello ius osculi. Basium, da cui deriva bacio, era
quello affettuoso che si dava alla moglie e ai figli. Savium, era il bacio
passionale o erotico. Derivava da suavis, dolce. L’usanza di baciare una donna
affonda nella notte dei tempi e lo scopo era controllare se la donna avesse
bevuto. Una legge antichissima le vietava di bere vino, dando al marito il
diritto di controllarla e ripudiarla, se lo riteneva opportuno o in casi
estremi di rinchiuderla in una stanza della casa e lasciarla morire di fame o
ucciderla a bastonate.
La ragione di questa punizione cosi severa stava nel facile
tradimento che poteva scaturire. I parenti del marito annusavano la presunta
colpevole per confermare l’accusa del marito. Talvolta erano proprio i parenti
ad accusarle, per salvare l’onore della gens, qualora il marito non se ne accorgesse.
Poi, lo ius osculi, diritto all’assaggio, favorì la diffusione dell’herpes
labialis, inducendo Tiberio a proibirlo per sconfiggere l’epidemia. Anche in senato
i baci erano comuni, come riconciliazione o nelle pari dignità. Vi era anche l’usanza
di baciare le mani alle persone più importanti, tutte tradizioni giunte ai
nostri giorni.
Nel privato c’era una grande libertà sessuale. La
prostituzione era molto diffusa e non disprezzata. A Roma si contavano ben 32.000
prostitute, tra schiave e donne libere della plebe, le postribulae, schedate in
appositi registri. Il 23 aprile e il 25 ottobre si celebravano le loro due
feste con una processione sacra al tempio di Venere Ericina. Molti erano bisessuali
e l’amore omosessuale era consentito. Catullo dichiarava il suo grande amore
per Lesbia e le sue aspirazioni omosessuali. Cicerone era attivo con il suo
servo e Adriano se la spassava con i giovani. Era infamante per un maschio
essere penetrato o ricevere la fellatio da una persona di classe sociale
inferiore. Il sesso orale non era ben visto, mentre era considerato normale il
sesso anale. Si diceva che chi praticava il sesso orale, aveva l’alito pesante
e non era gradito a tavola come ospite.
Le famose orge dei Romani furono pura propaganda
cristiana, poiché non erano praticate. Le uniche orge praticate erano quelle dionisiache
che non prevedevano il sesso, ma ebbrezza con l’ausilio di erbe o vino. Durante
il periodo imperiale, le infedeltà delle mogli non furono represse e le
separazioni divennero comuni e permesse, se il marito restava troppo a lungo in
guerra. La moglie, per contratto, poteva essere ceduta dal marito a un amico, legalizzando
un adulterio già esistente.
Nel tardo impero, per interferenza della Chiesa fu
dichiarato reato la omosessualità, detto stuprum. Da quel momento in poi, la Chiesa
ha perseguitato gli omosessuali e la sessualità, considerata positiva solo nel
caso di procreazione, da consumare senza provare gusto. Alla donna era vietato
il ruolo di sacerdotessa, ma poteva pregare, lavorare gratis per i preti e
sottostare alle loro leggi. Il diverso era mandato al rogo, come le streghe.
Tutti i tempi pagani furono distrutti, poiché erano la casa del diavolo, oppure
convertiti in tempi cristiani.
L’uomo Romano,
il Civis Romanus, era bisessuale, non per scelta quanto per imporre il potere, spronato
fin dall’infanzia a dominare e imporsi ovunque; in guerra, sui popoli nemici,
con le armi e le leggi; in politica, nella società e su persone di rango
inferiore, con la ricchezza o lo status sociale. Il Pater Familias, padrone
assoluto usava il suo organo sessuale per procreare, dare piacere e imporre il
dominio sugli altri. L’uomo che desiderava avere rapporti extraconiugali,
doveva farlo con individui di rango inferiore ed evitare in caso di gravidanze
che il nascituro un giorno potesse reclamare l’eredità. Non doveva mai fare
sesso orale a una donna, poiché ritenuto un atto di sottomissione. Nella prima notte di matrimonio se il marito non riusciva
a deflorare la sposa, quest’ultima doveva deflorarsi con una immagine in legno
del dio Priapo, il quale era rappresentato seduto con un enorme fallo eretto.
Per avere energia sufficiente ad affrontare la prima notte di nozze, le madri
degli sposi collocavano un bicchiere di miele vicino al letto. Seneca considerava fortunato il marito la
cui moglie si contentava di due amanti. Un epitaffio recitava: “Rimase per
quarantun anni fedele alla stessa moglie.” Una rarità. Marziale fu il più grande divulgatore
della vita sessuale sfrenata dei Romani.
Nelle
famiglie dell’alto ceto, quando un ragazzo raggiungeva la pubertà, il padre lo
accompagnava a un primo appuntamento con una prostituta. Le ragazze invece
dovevano arrivare illibate al matrimonio. La verginità prematrimoniale non era
solo una prerogativa delle famiglie nobili. Anche i ceti più bassi tendevano a
imitare i comportamenti delle famiglie ricche, sia per darsi un tono e sia
nella speranza che le ragazze avrebbero potuto sposare un uomo dell’alta
società.
L’adulterio si consumava quando un uomo aveva
relazioni sessuali con una donna sposata. Le relazioni con prostitute o schiave
non erano considerate adulterio. Augusto, con la lex adulteriis coercendis, del
17 a.C., colpiva severamente chi commetteva questo reato. Il marito era
obbligato a divorziare, pena l’accusa di proxenitismo. Il marito e il padre
della donna avrebbero potuto ammazzare l’amante se sorpreso in flagrante con un
plebeo. Le sanzioni per entrambi erano la perdita dei beni e l’esilio. Poi, la
donna era obbligata a indossare uno speciale vestito e non poteva risposarsi,
collocata nello stesso status delle prostitute.
Il sesso a Roma
era molto praticato, anche con le prostitute, le quali costavano pochissimo.
Tali donne avevano il problema di non dover restare incinta, quindi doveva
usare dei metodi contraccettivi, i quali erano fatti con del budello di
animali. Le donne prendevano dei piccoli gomitoli di lana, i quali, impregnati
di grasso, venivano posti nella vagina per impedire agli spermatozoi di fare il
loro tragitto. Poiché il problema non era sempre risolto, quando veniva
inseminata si procedeva all’aborto, pratica brutale che metteva a rischio la
vita della donna, tramite violenti movimenti, tramite salassi o bagni bollenti.
Il parto cesareo era praticato quando la madre moriva, per salvare il
nascituro.
Il
lupanare era un’istituzione sociale, tesa a soddisfare le molteplici tendenze
sessuali. L’ingresso conduceva in una sala dove c’erano delle celle chiamate fornices
che originarono il verbo fornicare, oppure cellae meretriciae, con letti in muratura. Sulle porte
d’ingresso e le pareti delle celle c’erano delle pitture murali erotiche che
specificavano le specialità delle prostitute. Nei posti più raffinati i letti
erano in legno, le stanze più rifinire e la biancheria pulita. Una sedia, un
tavolino, un catino, una brocca e un asciugamano completavano lo scenario. A
Pompei sono stati trovati oltre trenta bordelli, alcuni molto modesti. I
lupanari a Roma erano riconoscibili da una particolare lanterna e dagli organi
maschili disegnati sull’ingresso principale. A Roma i mestieri più
infamanti erano quelli dell’attore, di chi praticava l’usura e della
prostituzione. Se un patrizio doveva andarci, si camuffava con una parrucca o
coprendosi il volto con una maschera.
Nel
I secolo fu vietato l’introduzione nei lupanari di monete con l’effige
imperiale. All’uopo fu coniata una moneta, chiamata spintria, tessera in
bronzo, larga due centimetri, raffigurante una scena erotica su di un lato e un
numero sull’altro che rappresentava il valore economico espresso in assi, per
il pagamento delle prostitute. A Roma i bordelli erano diffusi nella Suburra e
attorno al Circo Massimo. Oltre che nei lupanari, la prostituzione era
praticava nei bagni pubblici, nelle taverne e nelle botteghe. Le prostitute
erano chiamate lupe, dalle quali derivava la parola lupanare. Ce n’erano anche
per omosessuali, frequentati anche da schiavi e gladiatori.
Tutte
le opere filosofiche e letterarie Greche e Romane, a sfondo omosessuale, furono
distrutte dai cristiani. Prima della conquista della Grecia i rapporti
omosessuali a Roma erano osteggiati e giudicati riprovevoli. La pederastia era
il vizio dei Greci, i quali giudicavano non solo le prestazioni dei ragazzi, ma
anche le sue virtù, al contrario che a Roma, dove si badava alla bellezza e
alle dimensioni del pene, anche se nelle statue, imitando quelle Greche era raffigurato
piccolo. Con la conquista della Grecia, i Romani praticarono l’omosessualità con
gli schiavi e i liberti. Un liberto poteva intrattenersi con schiavi e
prostitute, ma era immorale avere una relazione con la moglie di un libero
cittadino, con una ragazza o un ragazzo minorenne di buona famiglia o con un
cittadino libero adulto. Il Romano doveva sempre dominare e mai essere dominato,
penetrare e mai essere penetrato, per cui la penetrazione anale o il sesso orale
era riservata alle prostitute e agli schiavi. Anche per le donne era disonorevole
dedicarsi al sesso orale.
Le prostitute consideravano la fellatio la
pratica più ripugnante che un cliente potesse chiedere e quindi anche il più
costoso. Il cunnilingus era praticato a pagamento da alcuni uomini, verso
quelle donne che lo richiedevano. Queste pratiche degradanti per l’esecutore,
se scoperte, gli impedivano di votare. Le prostitute erano obbligate a vestirsi
di una tunica nera e corta, per differenziarsi dalle altre donne. La statio
cunnulingiorum era il posto dove le prostitute offrivano solo sesso orale.
Messalina, sposa dell’imperatore Claudio,
aveva affittato una cella per saziare il suo appetito sessuale che praticava
con lo pseudonimo di Licisca. Una volta scommise con altre prostitute che
sarebbe riuscita a soddisfare un’intera centuria. Inutile ricordare che vinse
la scommessa. Dove c’era un accampamento di soldati, non tardavano a
presentarsi un manipolo di prostitute. La moralità dei giovani Romani non era lodevole. A sedici anni cominciavano
a frequentare lupanari, bische clandestine e osterie. I bordelli dell’età
imperiale erano lussuosi e prima del servizio richiesto, i clienti erano
intrattenuti con danze e musiche. La menta era considerata un afrodisiaco e durante una guerra
era proibita per non debilitare i soldati. Davanti a una corte, il popolino
giurava di dire la verità, stringendosi i testicoli. Da qui la parola testare.
Testimoniare.
Una
delle donne di spettacolo più famose nella storia di Roma, si chiamava
Licoride. Grazie alle sue doti amatorie frequentava la classe alta e anche
Cicerone la frequentò. Era una donna bellissima in tutte le sue fattezze,
grande amante e procacciatrice di eredità. Vi furono altre due artiste simili
che tennero testa a Licoride, sia sul palcoscenico, cantando e danzando, sia
tra i guanciali. Si chiamavano Arbuscola e Origine. Quest’ultima, in una delle
sue tante imprese fece perdere la testa a un ragazzo di nobile e ricca
famiglia, chiamato Marseo, il quale perse tutto il suo patrimonio per andarle
dietro. Arbuscola, come la precedente, vissuta
nel I secolo a.C., fu la protagonista di una commedia di Orazio, dopo averla
sentita inveire contro il pubblico che la fischiava in un suo spettacolo, con
la famosa frase: “Satis est equitem mihi plaudere.” Mi basta che applaudano i cavalieri. La frase è rimasta
nel lessico, a indicare superiorità verso rozze critiche e in maniera dispregiativa verso chi utilizza la
propria arte solo per ingraziarsi i favori dei potenti.
Licoride,
nata nel 70 a.C., era una donna desiderata da tutti gli uomini, riuscendo a farsi
strada in una società maschilista, partendo dal teatro. Licoride era il suo
cognome, Volumnia il suo nome onomatopeico. Il nome d’arte era Citeride, dall’isola
di Citerà, lì dove nacque Venere. Licoride era una schiava di Publio Volumnio
Eutrapelo, uomo ricco e inserito nel mondo dello spettacolo. I suoi attori e le
sue attrici erano destinati agli spettacoli teatrali o a intime prestazioni
nelle ville dei potenti dell’epoca. Si trattava di una schiava e così per
inserirla nell’alta società, la liberò. La sua prima relazione importante
l’ebbe nel 50 a.C., con Bruto. Qualche anno dopo, nel 49 a.C., fu amante di
Marco Antonio, il quale frequentava la mondanità Romana. Fu Volumnio a spingere
Licoride nelle braccia di Marco Antonio, per accrescere il suo potere e
Licoride non si fece pregare. La loro unione destò molto scalpore a Roma, poiché
entrambi erano famosi. All’epoca Marco Antonio era già sposato, ma andava in
giro in lettiga con Licoride, per le strade di Roma, trattandola come una
matrona. Questo avrebbe potuto rovinare non la reputazione di Marco Antonio,
già ampiamente compromessa, quanto la sua carriera politica e militare. Passata
la sbornia, dopo tre anni, nel 46 a.C., Antonio ruppe la relazione, anche per
le pressioni che Giulio Cesare esercitava.
Nel 43 a.C.,
Licoride era nell’alcova di Cornelio Gallo, poeta elegiaco, parte del circolo
letterario di Virgilio e Ovidio. Cornelio s’innamorò perdutamente di Licoride, la
quale divenne sua musa ispiratrice. Poco dopo lei decretò la fine della storia,
lasciandolo distrutto. Donna pragmatica e volitiva, stanca di melense poesie,
decise di fuggire con un ufficiale dell’esercito Romano, Quinto Fufio Caleno,
fedelissimo di Giulio Cesare, alla ricerca di nuovi orizzonti monetari.
Licoride, dopo quest’ultimo colpo di testa, scompare dagli annali, ma molti secoli
dopo molte meretrici si facevano chiamare Licoride e la sua gloria è giunta
sino a noi, inalterata.
Testo tratto dal libro sull'Impero Romano:
"Voci dall'Antica Roma"
2025 by Enzo Casamassima. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission.